L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Il volto del secolo. La prima cellula dell'architettura razionalistica italiana
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti

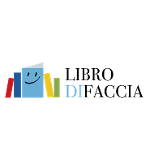



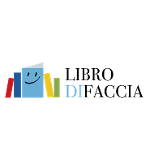

Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (0)

recensione di d'Orsi, A., L'Indice 1989, n.10
Per troppo tempo la storia dell'architettura del '900 è stata affidata soltanto a specialisti del settore. E dire che tra i primi, forse il primo in assoluto, almeno nel nostro paese, a tentare una storiografia dell'architettura del '900 fu un tale che architetto non era. Irregolare negli studi, come nella collocazione professionale, nella sua breve esistenza Edoardo Persico ci ha lasciato, per la verità, soltanto frammenti di un discorso interrotto, gravati, per di più, da un profetismo spiritualistico, assai lontano dalla nostra concezione del "moderno", di cui proprio il critico napoletano fu assertore e teorico. E nondimeno Persico è stato fra i suscitatori e gli aggregatori del razionalismo architettonico italiano, filiazione tardiva e ibrida del movimento modernizzatore euroamericano d'inizio secolo, cui la prima guerra mondiale diede un impulso decisivo.
A Persico, non a caso, sono dedicate alcune delle pagine più vive del libro di un suo coetaneo, uno che, come lui, stava fra gli architetti come un missionario 'in partibus infidelium'. Giornalista, pittore, musicista, ed altro ancora, Carlo Belli è sopravvissuto a Persico per oltre un cinquantennio, dopo aver dato un notevole contributo, da comprimario, alle vicende teoriche ed organizzative della cultura artistica e architettonica italiana, dalla milanese Galleria del Milione alla rivista romana "Quadrante". Ora, dal vertice dei suoi ottantacinque anni, egli può realizzare un'efficace visione prospettica di iniziative, attese e disillusioni di quelle pattuglie di architetti che, a partire dagli ultimi anni Venti, tentarono l'importazione nella patria della romanità, e del suo appena rinnovato culto, dei principi del funzionalismo. In particolare, il libro, che in appendice riporta alcuni interessanti articoli pubblicati dall'autore in varia sede fra il '31 e il '36, narra la storia del "Gruppo 7" dalla sua nascita a Milano nel 1926 e il suo successivo arricchirsi di uomini e idee fino all'assorbimento nel MIAR (Movimento Italiano per l'Architettura Razionale) nel 1931, il rapido inabissarsi di quest'ultimo e il conseguente sbandamento dei razionalisti.
Opera di un testimone, quindi, questa del Belli, che però non si limita a frugare nelle malcerte pieghe della memoria personale, al fine dell'autodifesa e dell'autoapologia, secondo la prassi costante del genere memorialistico. Naturalmente, non c'è un lavoro da storico alle spalle della narrazione, che tuttavia si fonda su materiali documentari non spregevoli, oltre che sulla vivace verve rievocativa dell'autore. Il risultato al di là dell'interesse e della vicenda raccontata è uno stimolante percorso all'interno del fascismo, dei suoi sforzi modernizzatori e delle sue remore passatiste, della "servitù volontaria " (per riprendere una celebre espressione di Francesco Flora) degli intellettuali e del loro sia pure imperfetto inserimento nelle strutture ideologico-organizzative del regime. In tale direzione, in sostanza, troviamo qui un'ulteriore conferma di quelle modeste, ma essenziali verità che la storiografia è andata scavando a proposito della "cultura del fascismo": è noto che, nel corso degli ultimi due decenni, la ricerca fascistologica pur subendo le opposte remore - ma altresì gli stimoli - della fermezza un po' stagnante del ciellenismo storiografico da una parte, e dell'aggressivo revisionismo di marca defeliciana dall'altra, ha compiuto notevoli passi in avanti proprio sul variegato ed accidentatissimo terreno della cultura. Gli studi locali, le monografie su personaggi minori (gli intellettuali "funzionari" su cui aveva attirato l'attenzione Isnenghi), le stesse messe a fuoco della portata politico-organizzativa e mercantile del lavoro intellettuale dei grandi numi, l'insistere sull'importanza dei centri aggregatori come le riviste, i giornali, le accademie e, soprattutto, le case editrici, hanno un po' alla volta relegato tra i ferrivecchi il preteso discrimine ideologico: i fascisti (pseudointellettuali, se autentici fascisti; pseudofascisti, se intellettuali autentici) da un canto; dall'altro, gli antifascisti (depositari della vera cultura, fedeli agli ideali di libertà anche quando avevano, "nicodemisticamente" aderito sul piano formale al regime).
Oggi, chi voglia seriamente occuparsi delle vicende della cultura fra il '22 e il '43 deve insomma essere consapevole che la contrapposizione fascismo/antifascismo è inutile e fuorviante, non in quanto pregiudizio ideologico ma in quanto artificio storiografico. La testimonianza di Belli - tutt'altro che scevra da giudizi e pregiudizi di carattere ideologico: l'autore non stenta a farci capire di essere uno di quelli che ci aveva creduto, n‚ si sarebbe ricreduto se il regime non avesse tralignato... - finisce per portare, certo inconsapevolmente, nuova acqua a codesto mulino, proprio perché, trattando di architetti, vale a dire di tecnici che erano deputati all'edificazione, non può sottovalutare la questione essenziale: la committenza.
I razionalisti vorrebbero dunque "rimettere l'Italia in Europa" (p. 77), ritenendo di dover compiere un lavoro di informazione e revisione analogo a quello che la "Voce" di Prezzolini aveva intrapreso vent'anni prima. Tali battaglieri propositi vengono a stemperarsi in primo luogo per le intime contraddizioni e debolezze dei loro autori: anche quando non si elaboravano cose "appena biascicate, incerte quando non brutte addirittura" (p. 59), "rispetto ai grandi Maestri stranieri, i nostri razionalisti parlavano ancora quasi tutti in dialetto" (p. 65).
Ma più che le incertezze teoriche, o le carenze culturali di quei giovani, li perdé, se così possiamo dire assumendo un po' dell'enfasi appassionata di Carlo Belli, il loro stesso desiderio di lavorare: dopo qualche anno "di assidue e infruttuose progettazioni, quei giovani cominciavano ad essere stufi di tirar righe. Volevano ordinazioni: avevano sete di cemento, di ferro, di vetri, di mattoni". (p. 55). Ma, all'epoca, le ordinazioni si identificano pressoché totalmente con le commesse pubbliche: e per ottenerle occorre passare attraverso il Sindacato; ma soprattutto occorre essere pronti a cavalcare tutte le tigri in campo, specie davanti all'inerte, gigionesca oscillazione mussoliniana fra archi e colonne da un lato, le quadrate, ampie finestre dall'altro.
Riferendo della inattesa convocazione a Palazzo Venezia dei progettisti di Sabaudia e della stazione di Firenze, nel giugno '34, Belli si esalta ancora per le "belle e sante parole" del duce (p. 136) che sembrano annunciare la vittoria dei razionalisti, e invece preludono alla loro disfatta. Seguendo lo schema del nostalgismo fascista più classico, Belli mostra di credere alla sincerità dell'adesione mussoliniana alle idee svecchiatrici, moderniste ed "europee" dei razionalisti. Ma il "capo" era "irretito e soggiogato" da quei "maestri del compromesso e dell'inganno che allora tenevano le chiavi di Palazzo Venezia", "fantocci", sì, dal duce creati, ai quali tuttavia egli finiva per soccombere (pp. 132-33).
Altrettanto ingenua appare del resto la contrapposizione estrema, che percorre l'intera rievocazione di Belli, fra i difensori del "vecchio " e i propugnatori del "nuovo ", gli uni e gli altri alla ricerca del definitivo verbo fascista in fatto di architettura, in sintonia con lo stile della nuova era. È del resto oltre modo significativo che, in termini di quantità e qualità delle commesse, la vittoria arrida, contro gli eccessi del romanismo alla Ojetti e l'estremismo razionalista, a Marcello Piacentini, che con il suo "ambiguo modernismo" (p. 137) capace di accontentare i monumentalisti di regime ma di solleticare i funzionalisti di buona bocca, darà un volto ed un nome all'architettura del fascismo. Il trionfo di Sua Eccellenza implica il "crollo finale" (p. 138) dei razionalisti: la città razionale sarà null'altro che utopia.
È la metà degli anni trenta: il regime compie la sua definitiva svolta all'insegna di una ri-fascistizzazione della società nazionale. Le battaglie della cultura si addomesticano: le logiche pur non lineari del mercato, in una combinazione funesta con gli estremi deliri di potenza del regime, sbaragliano il campo. Talché l'esito miserando delle vigorose polemiche fra le due (o tre) linee della cultura architettonica del decennio precedente è null'altro che la vittoria di quell'insieme di spinte speculative borghesi, di esaltazione della rendita fondiaria e di attivo e distorcente intervento del potere politico che va sotto il nome di "blocco edilizio". Lo sfascio delle città italiane e il degrado della cultura architettonica nazionale, i cui segni lugubri sono sotto i nostri occhi, trovano un punto d'avvio, o, a seconda dei casi, di decisa accelerazione, proprio nella battaglia, ambigua e perduta, della "prima cellula del razionalismo italiano".
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


