L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Teorie e metodi del restauro delle vetrate nell'Ottocento
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti



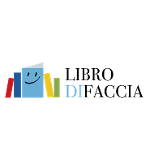


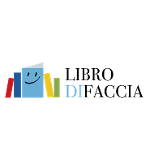
Tutti i formati ed edizioni

Quanti conservino impresso il ricordo delle opere di Ingres per gli ampi finestroni di Dreux o di Neuilly, o delle vetrate neomedievali di Maréchal de Metz in Saint-Vincent-de-Paul a Parigi, resteranno piacevolmente colpiti nel constatare la ricchezza e l'interesse dei materiali indagati da Silvia Silvestri in questo bel libro. Per quei lettori che non denunciassero familiarità con tale produzione la sorpresa sarà tanto più intensa e inattesa. Anche solo sfogliando le numerose tavole a colori di questo tomo, si preparino al disvelarsi di un ambito della storia dell'arte italiana del XIX secolo decisamente mal noto, un nuovo tassello da apporre al complesso intarsio dell'identità artistica dell'Ottocento europeo.
Il volume prende le mosse dalla riconsiderazione di un luogo comune della storia dell'arte del nostro paese: quello secondo cui gli edifici (pubblici e privati, ecclesiastici e civili) non preservino che rare e pallide testimonianze dell'arte della pittura su vetro, tecnica assai più affermata oltralpe, particolarmente in Francia e in Germania, tanto da essere definita "arte francese". Se si deve agli studi di Enrico Castelnuovo la consapevolezza che questo preconcetto "vasariano" abbia influito negativamente sulla fortuna critica della produzione vetraria italiana di età medievale e moderna, Silvestri si spinge cronologicamente avanti nella sua revisione, incentrando la propria ricerca sulla produzione di vetrate compresa tra il 1820 e il 1870. È infatti nell'Ottocento della Restaurazione, tra Romanticismo e Purismo, che il recupero della finestra istoriata e l'apprezzamento della sua preziosità anche simbolica, divulgata da letterati come Victor Hugo e da architetti come Viollet-le-Duc, giocano un ruolo non indifferente nell'ambito della riscoperta degli stili che impegna non solo la Francia, l'Inghilterra e gli stati della Germania, ma anche la cultura artistica italiana, stimolata da un costante rapporto con le esperienze europee. Coerenti e fedeli alle promesse, come di rado accade, sono infatti il titolo, il sottotitolo e la collocazione del volume nella collana "Italia e Francia. Studi di storia dell'arte"dell'Institut national d'histoire de l'art.
Il panorama italiano delle sperimentazioni ottocentesche nella pittura su vetro è dispiegato attraverso una sapiente tessitura costruita sull'ordito della pubblicistica del tempo e della disamina dei materiali sopravvissuti e perduti. Il quadro degli scambi, delle contaminazioni (specialmente con la Francia), delle presenze straniere ne esce rafforzato anche quando viene determinata con precisione la peculiarità delle identità locali. Le fonti contemporanee, la documentazione d'archivio, l'analisi diretta dei monumenti e della loro ricezione costituiscono l'asse portante intorno al quale l'autrice ricostruisce una storia della vetrata artistica nell'Ottocento preunitario. Si tratta, è ovvio, di un racconto popolato da presenze già precedentemente acclarate dagli studi e da tempo valorizzate nelle raccolte museali (come nel caso delle manifatture milanesi), che risulta tuttavia arricchito da microstorie del tutto inedite (come nel caso della Roma pontificia) e per la prima volta unitariamente narrato.
Se ne ricava una mappatura assai precisa, in qualche caso curiosa, di sovente gustosa, delle esperienze più significative sul territorio italiano, cui corrisponde una parabola che si riflette nell'articolazione del volume. Dalla Milano romantica, dal Regno di Sardegna di Carlo Alberto sino all'Umbria postunitaria, con tappe nella città eterna e nel Granducato di Toscana, il lavoro di Silvestri affronta le personalità, i cantieri, le occasioni espositive attraverso cui l'arte della vetrata viene a declinarsi nell'Italia dell'Ottocento.
Gli argomenti esaminati sono numerosi. Milano assume il ruolo di capofila nelle vicende della vetrata artistica ottocentesca. Nel clima europeo di rivisitazione della storia medievale come epoca della nascita del sentimento nazionale, la città conosce per prima la divulgazione da parte degli studi storici dei pregi estetici e morali dell'antichità medievale, che diventa suggestione per fenomeni di costume. Come è stato osservato da Fernando Mazzocca, i nobili milanesi si calano nelle vesti degli eroi medievali e cominciano a voler "nascondere i loro ritrovi in certe tombe o cappelle mortuarie, tappezzate di velluto oscuro, colle finestre rimpicciolite da un doppio cortinaggio di damasco bruno e protette da vetrerie colorate, simili a quelle della antiche cattedrali gotiche". Al servizio di tale rinnovata sensibilità per il medioevo, che assume ben presto connotazioni nazionalistiche legate alla tradizione delle vetrate del Duomo, non tardano a sorgere piccole imprese pronte a introdurre in Italia dalla Francia la novità della pittura su vetro, d'ispirazione laica o religiosa. Giovanni Bertini, Luigi Brenta, Pietro Bagatti Valsecchi, e il talentuosissimo Giuseppe Bertini ne sono i principali protagonisti. Il passaggio dalla committenza privata alle commissioni pubbliche è subitaneo e il successo nazionale giunge assai prima della stessa fondazione della nazione. È Giovanni Bertini l'uomo d'oro della prima stagione della vetrata istoriata in Italia; il suo restauro dei finestroni del Duomo di Milano, che vengono allestiti con "nuovi vetri", segna una svolta che trova paralleli e sincronie in Francia nei numerosi restauri delle vetrate antiche di edifici ecclesiastici.
Il nesso tra restauro, studio e rifacimento delle vetrate medievali costituisce uno snodo di primaria importanza non solo per la carriera di Bertini, quanto per l'intero sviluppo della vetrata figurata in Italia, che trova il suo apice nel 1838, quando il camerlengo della Santa Sede affida al maestro milanese il restauro delle vetrate della Basilica Superiore di Assisi, ben presto oggetto di vivaci contestazioni. La dimensione della ricerca tecnologica e della risoluzione dei problemi tecnici legati al restauro si manifesta nelle forme più diverse. Nel Granducato di Toscana la sperimentazione di nuove tecniche è sempre legata alla salvaguardia del patrimonio. Nella roccaforte del gotico, l'impegno maggiore degli anni quaranta è costituito dalla conservazione dei monumenti del camposanto di Pisa, operazione che dà luogo alla costituzione di maestranze specializzate votate a intervenire sul patrimonio vetrario, ma anche alla ricerca di interventi allogeni, francesi (del protagonista della manifattura di Metz, Charles-Laurent Maréchal, promulgatore di un nuovo stile archeologico) e milanesi (dello stesso Bertini). La ricerca di nuove tecnologie in grado di proporre materiali vitrei adatti al restauro delle antiche finestre fa sì che ampio credito venga concesso, per esempio, al pisano Guglielmo Botti, che con il restauro dei vetri oggi perduti della chiesa di San Paolo al Ripa d'Arno e delle vetrate nel Battistero tenta una rinascita dell'arte vetraria romanica, con esperimenti alla ricerca di "una materia colorante necessaria per i chiaroscuri, e fusibile al tempo stesso" di stampo francese.
Pur essendo molto più aperta e cosmopolita di quanto si tenda a riconoscere, Roma assorbe solo una parte delle esperienze vetrarie del tempo: la famiglia Torlonia, in pieno rispetto della moda europea, accoglie nei suoi palazzi i vetri milanesi di Bertini; le suore francesi del Sacro Cuore ordinano vetri colorati per la loro cappella a Hallenkirche, i domenicani di Santa Maria sopra Minerva adeguano la loro primitiva chiesa allo stile gotico con l'aiuto di Bertini, artisti domenicani francesi educati a Metz, centro vetrario di prima importanza, come il finora poco noto fra' Marcellino di Metz, operano in Santa Sabina e in Sant'Alfonso de' Liguori, uno dei rarissimi cicli decorativi sopravvissuti allo scoppio della polveriera che, nel 1891, mandò in frantumi tanti vetri romani.
A mortificare quella che poteva essere la "sfida dell'arte monumentale trasposta su vetro" è, negli anni cinquanta, l'applicazione del diritto di privativa concesso da Pio IX ad Antonio Moroni, vetraio ravennate, in eterno conflitto con quanti, francesi o di altra nazionalità, volessero intervenire sui restaurandi o erigendi vetri dello Stato Ponticio. Negli anni sessanta, laboratorio particolarmente fervido per questa produzione di arte applicata diventa Perugia, dove sulle esperienze dei Francisci si innestano quelle di Francesco Moretti, unico italiano a ottenere ottime critiche all'Esposizione internazionale di Parigi del 1867. Sarà un successo a tempo determinato. Le caratteristiche della cultura figurativa di questo maestro, fedele agli stili del passato e alla tecnica della vetrata tradizionale, escluderanno Moretti dalla virata impressa dall'Art Nouveau proprio a partire dalle arti applicate, rendendo il suo lavoro presto obsoleto. Quello di Moretti, però, conclude acutamente l'autrice, non sarà un insegnamento perduto. "Le ragioni della competenza tecnica e della sensibilità alla linea di Cambellotti, Picchiarini, Bottazzi, Paschetto, Beltrami e Chiesa, ideatori di opere in vetro tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo a Roma e in Lombardia" saranno eredi delle acquisizioni tecniche, della pratica consolidata nell'uso di colori e trafile, ossia matura conseguenza del "naturale compiersi del percorso della storia della vetrata italiana dell'Ottocento", sapientemente tratteggiato in questo libro. Giovanna Capitelli
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri



