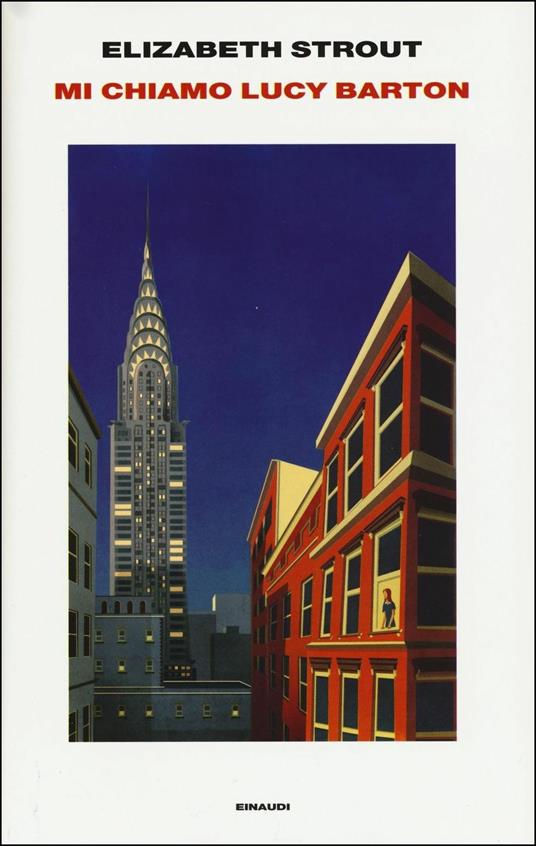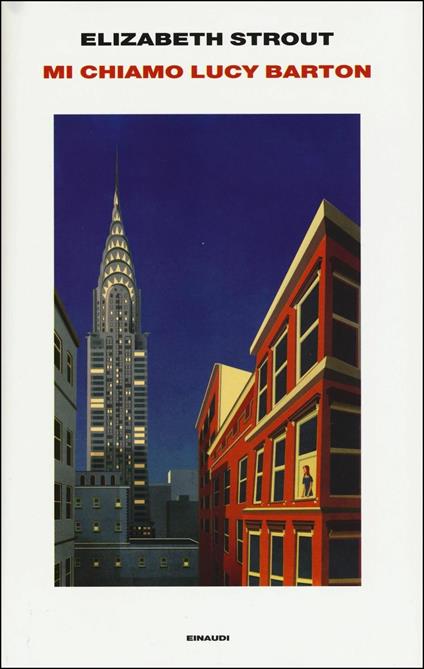L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Mi chiamo Lucy Barton
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2017

Anno edizione: 2016
Promo attive (0)
In una stanza d’ospedale nel cuore di Manhattan, davanti allo scintillio del grattacielo Chrysler che si staglia oltre la finestra, per cinque giorni e cinque notti due donne parlano con intensità.
«Un romanzo perfetto, nelle cui attente parole vibrano silenzi. Mi chiamo Lucy Barton offre una rara varietà di emozioni, dal dolore piú profondo fino alla pura gioia». - Claire Messud, The New York Times
«Strout si conferma una narratrice grandiosa di sfumate vicende famigliari, capace di tessere arazzi carichi di saggezza, compassione, profondità. Se non l’avesse già vinto con Olive Kitteridge, il Pulitzer dovrebbe essere suo per questo nuovo romanzo». - Hannah Beckerman, The Guardian
Deve essere il sistema che adottiamo quasi tutti per muoverci nel mondo, sapendo e non sapendo, infestati da ricordi che non possono assolutamente essere veri. Eppure, quando vedo gli altri incedere sicuri per la strada, come se non conoscessero per niente la paura, mi accorgo che non so cos'hanno dentro. La vita sembra spesso fatta di ipotesi. - Elizabeth Strout
Da tre settimane costretta in ospedale per le complicazioni post-operatorie di una banale appendicite, proprio quando il senso di solitudine e isolamento si fanno insostenibili, una donna vede comparire al suo capezzale il viso tanto noto quanto inaspettato della madre, che non incontra da anni. Per arrivare da lei è partita dalla minuscola cittadina rurale di Amgash, nell'Illinois, e con il primo aereo della sua vita ha attraversato le mille miglia che la separano da New York. Alla donna basta sentire quel vezzeggiativo antico, "ciao, Bestiolina", perché ogni tensione le si sciolga in petto. Non vuole altro che continuare ad ascoltare quella voce, timida ma inderogabile, e chiede alla madre di raccontare, una storia, qualunque storia. E lei, impettita sulla sedia rigida, senza mai dormire né allontanarsi, per cinque giorni racconta: della spocchiosa Kathie Nicely e della sfortunata cugina Harriet, della bella Mississippi Mary, povera come un sorcio in sagrestia. Un flusso di parole che placa e incanta, come una fiaba per bambini, come un pettegolezzo fra amiche. La donna è adulta ormai, ha un marito e due figlie sue. Ma fra quelle lenzuola, accudita da un medico dolente e gentile, accarezzata dalla voce della madre, può tornare a osservare il suo passato dalla prospettiva protetta di un letto d'ospedale. Lì la parola rassicura perché avvolge e nasconde. Ma è nel silenzio, nel fiume gelido del non detto, che scorre l'altra storia.
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.
Non si può ricucire un rapporto fatto solo di incomprensioni e parole non dette.
Pagina dopo pagina ho avuto la sensazione che l'autrice stesse provando a dire qualcosa senza mai riuscirci. Ci sono libri che non dicono, ma che riescono a farti capire tutto lo stesso. Questo no. E che l'effetto fosse voluto oppure accidentale non importa, il risultato è comunque un libro sterile.
è un libro che non mi aspettavo potesse piacermi ma mi ha letteralmente sorpreso in positivo.
Recensioni
Recensioni pubblicate senza verifica sull'acquisto del prodotto.

Una mattina mi sono seduta sul divano con questo libro in mano e mi sono alzata, una volta finito, provando una nostalgia infinita di quel tempo in cui le persone erano gentili. L’ho poi recensito qui, perché è davvero un libro pieno e argenteo.
Marta

Dopo una semplice operazione all’appendice, Lucy, madre di due bambine, viene trattenuta in ospedale per nove settimane a seguito di alcune complicazioni, un batterio misterioso a cui nessuno riuscirà a dare nome. Cinque giorni di quel lungo periodo di degenza Lucy li passa con sua madre, che dall’Illinois arriva nella stanza di ospedale di New York da cui si vede il grattacielo della Chrysler. Elizabeth Strout fa iniziare il suo ultimo libro da qui: dall’incontro tra una madre e una figlia.
Mi chiamo Lucy Barton è, prima di tutto, un romanzo sull’arte di narrare storie. Ci sono le storie degli altri, raccontate dalla madre di Lucy nella stanza di ospedale: come una bambina che non riesce ad addormentarsi, Lucy, «Bestiolina», chiede a sua madre «raccontami ancora». E così la stanza anonima dell’anonimo ospedale newyorkese si popola di figure che arrivano dalla provincia.
Ci sono le storie delle persone che Lucy ha incontrato nel suo cammino che l’ha portata lontana dalla provincia: i maestri che ha avuto da bambina, l’artista di cui è stata innamorata al college, e poi Jeremy, Molla, la scrittrice Sarah Payne, il dottore a cui Lucy vuole bene, e suo marito William. C’è la storia della famiglia di Lucy, che ha vissuto in un garage ad Amgash, che sempre si è vergognata della propria miseria, che ha mangiato pane e melassa per cena e ha sofferto l’inverno e gli sguardi di chi l’ha compatita. C’è la storia di Lucy, narrata in prima persona, che inizia sì in quella stanza d’ospedale ma che si muove tra passato e futuro, abbracciando l’infanzia della protagonista fino ad arrivare alla sua vecchiaia: in mezzo, ci sono quei cinque giorni di ospedale, l’ultima vera occasione per sentirsi dire dalla propria madre «ti voglio bene».
Il mestiere di scrivere
E c’è poi una vera e propria riflessione sul mestiere della scrittura: perché prima ancora di essere un io narrante, Lucy è una scrittrice, e nel corso del libro non fa che riflettere su questa sua condizione, sulla necessità della scrittura. Così quando il lettore meno se lo aspetta, Elizabeth Strout, nei panni dei propri personaggi, risponde a delle domande centrali per chi cerchi di penetrare il mistero della scrittura. «E quale sarebbe il suo mestiere come romanziera?’, fece lui. Il suo mestiere come romanziera era riferire della condizione umana, raccontare chi siamo e cosa pensiamo e come ci comportiamo». Poco importa che sia una risposta inserita nella narrazione romanzesca: noi lettori sentiamo che quello che la Strout ha deciso di fare con questo romanzo è proprio raccontare chi siamo e cosa pensiamo e come ci comportiamo.
La narrazione si muove non solo su diversi piani temporali, ma anche divisa tra città e provincia, tra il desiderio di tagliare per sempre i ponti con Amgash e il non sentirsi mai del tutto al proprio posto a New York. Quello che Lucy prova a fare è proprio conciliare queste due nostalgie: aggrapparsi con spietatezza a se stessa, scrivere di se stessa, perché dalla sua insegnante di scrittura ha imparato che «ciascuno ha soltanto una storia. Scriverete la vostra unica storia in molti modi diversi. Ma tanto ne avete una sola».
La parola di Lucy è limpida ma non si sottrae ai tentennamenti: non è raro che il discorso si interrompa, metta in dubbio se stesso, si interroghi sulla propria veridicità. Quello che sto raccontando è vero, o sono io che ricordo male?, si chiede spesso Lucy. Così la storia si nasconde nella reticenza e nel non detto, nei silenzi che pesano di più delle parole scritte.
Non è un romanzo per ragazze
Ma non chiamatelo un romanzo per ragazze, sembra dire continuamente Elizabeth Strout. Anche se le donne sono il cuore del libro; anche se le loro storie muovono la narrazione. Anche se nel romanzo è presente una profonda riflessione sulla maternità e i conflitti che la maternità porta con sé: quello tra essere madre ed essere figlia, quello tra essere donna ed essere madre. Nella stanza d’ospedale, Lucy ha bisogno di riconciliare lo strappo con sua madre, che mai l’ha davvero perdonata per essersene andata, per aver studiato, per aver abbandonato la provincia. E poi di nuovo, in un’altra camera, con sua madre questa volta malata, Lucy ha bisogno di dirle addio: di iniziare a vivere senza lei, la sua ombra che sempre l’ha schiacciata con il senso di colpa e di inadeguatezza, ma che l’ha anche protetta.
Nella scrittura, Lucy ha bisogno di rimarginare la ferita che si è aperta quando le sue figlie sono andate al college, e il suo matrimonio è fallito, perdendo il collante che aveva tenuto per tutti quegli anni Lucy e William insieme: la sicurezza di essere un padre e una madre, prima ancora di essere un uomo e una donna. La necessità di diventare di nuovo una donna e basta. Ma non chiamatelo un romanzo per ragazze: è un romanzo per chi, come Lucy, ha bisogno di dire Questo è mio. Questa persona sono io. Io mi chiamo Lucy Barton.
Recensione di Gabriella Dal Lago

C’è un’America che neanche sospetta dell’esistenza di un “sogno americano”. È fatta di persone che vivono in garage, furgoni, roulotte, di bambini che frugano nei cassonetti in cerca di caramelle, di padri reduci di guerra che coltivano granturco. I più coraggiosi di loro sono andati nel Midwest e hanno mandato via gli indiani, ma non sono da disprezzare, sono coloni che ce l’hanno fatta. Gli altri sono rimasti nelle loro cittadine di frontiera. Di questa America noi europei fino a poco tempo fa non sapevamo nulla. Le stelle e le strisce, Hollywood e la musica pop, non hanno mai raccontato questa terra desolata e stanca che produce le pagine di letteratura contemporanea più belle del mondo, forse senza saperlo.
Poi alcuni libri, di una bellezza “spietata”, finiscono nelle nostre case. Elisabeth Strout è una di queste autrici sorprendenti, capaci di raccontare l’America rurale con voce sincera e disarmante. Il nodo centrale della sua poetica è l’idea che nessuno sia in grado di conoscere veramente gli altri. Nel suo romanzo precedente, un libro corale, familiare, I ragazzi Burgess, il punto cruciale del racconto era proprio questo senso di incapacità di cogliere la vera natura delle persone, a cui si sopperisce spesso, nella provincia, con le chiacchiere e i pettegolezzi.
In questo nuovo romanzo, invece, la riflessione si fa più raffinata e introspettiva; il non detto, la pausa e l’attesa diventano gli elementi più significativi del romanzo.
In poco più di 150 pagine, la scrittrice premio Pulitzer racconta il rapporto tra una madre e una figlia interrotto molti anni prima, quando la ragazza lascia la casa dei genitori in Illinois per seguire gli studi. Da allora le due donne non si sono mai più riviste. Lucy, che nel frattempo si è sposata, ha avuto due figlie ed è andata a vivere a New York, non tornerà più nella misera casa dei suoi genitori, dove ha trascorso un’infanzia di privazioni. Il suo amore per la lettura e la sua naturale inclinazione alla solitudine le hanno consentito di andare al college grazie alle borse di studio, per poi intraprendere una piccola carriera di scrittrice.
Improvvisamente, però, tutto si ferma. La malattia irrompe nella vita di Lucy, che si vede costretta in un letto d’ospedale. Dalla sua finestra scintilla il grande grattacielo Chrysler, ed è l’unica cosa che riesce a vedere per molti giorni, visto che suo marito e le sue figlie, presi da numerosi impegni, le fanno visita molto di rado. Dopo i primi giorni di assoluto silenzio e torpore, senza preavviso, Lucy vede comparire accanto al suo letto sua madre.
È una visione quasi onirica all’inizio. I lineamenti sbiaditi, la voce stentorea e i sedativi rendono questa presenza soltanto tratteggiata, eterea. Poi le due donne, quasi che non fossero in effetti due estranee, iniziano a parlare. La madre, in maniera fitta e precipitosa, racconta le sue storie di provincia, di Kathie Nicely lasciata dal marito, di Annie Appleby che è diventata famosa e triste, del fratello che dorme nella stalla con gli animali che il giorno dopo andranno al macello. Chiacchiere che dicono tanto ma non rivelano niente di nessuno. Nemmeno una parola su suo padre e le sue crisi, nemmeno un accenno al loro matrimonio che si trascina come una peso da moltissimi anni, solo considerazioni superficiali e vacue sulle vite e i fallimenti altrui, chiamati in causa come fossero appigli per salvare se stessi. Ma a queste chiacchiere da cui è fuggita molti anni prima, Lucy adesso si aggrappa disperatamente, perché disperato è il bisogno di sentire sua madre vicina.
In questo libro troviamo un fulgido esempio di come un rapporto interrotto e tralasciato per anni, possa lentamente e a fatica riaffiorare in superficie. Nel racconto di Lucy c’è tutta la sua vita: i figli, gli studi, gli artisti che incontra a New York e il suo rapporto con la scrittura. Chiamarla auto-fiction sarebbe riduttivo, quasi offensivo. Elisabeth Strout racconta la storia di Lucy Barton calandosi nelle sue profondità più oscure, per poi risalire lasciando sulla pagina sprazzi di vita prismatica, illuminante.
Recensione di Annalisa Veraldi

La gentilezza degli estranei
Una mattina mi sono seduta sul divano con questo libro in mano e mi sono alzata poche ore dopo, una volta finito, provando una nostalgia infinita di quel tempo in cui le persone erano gentili.
Mi chiamo Lucy Barton di Elizabeth Strout è una storia molto intensa che – come può essere intensa una fiammata o un’onda o una canzone – inizia e finisce in un arco di tempo molto breve. Il tempo della lettura, intendo. Perché il tempo della storia è invece molto più lungo: 5 giorni in ospedale, che in realtà sono 9 settimane in tutto, che in realtà sono gli anni che intercorrono tra il momento della malattia della protagonista e quello della scrittura del libro. Anni di cui si raccontano solo istanti, incontri significativi, cambiamenti fulminei, rimpianti e nostalgie.
In quei 5 giorni in ospedale ci sono la protagonista e sua madre che, dopo molti anni di distacco e molte miglia di separazione, si rincontrano in una sospensione dolorosa e insieme consolatoria dell’orologio. In un alternarsi senza sonno di notti e di veglie, di cieli e di ricordi, il tempo sfuma e lo spazio svetta: i loro sguardi vanno al Chrysler di New York, i loro pensieri vanno ai campi di grano e soia dell’Illinois da cui entrambe provengono. Città e provincia, movimento e stasi, ricchezza e povertà: è come se quell’abbraccio madre-figlia in cui si stringono le due donne contenesse in sé – esclusivamente per la durata di quella parentesi di 5 giorni e 5 notti – tutti questi opposti.
Questi e anche tanti altri, in primis quello sotteso a ogni relazione incontrata nel romanzo: un opposto molto attuale, gentilezza e spietatezza.
Che atrocità che un marito non vada a trovare la moglie in ospedale per quasi due mesi. Che incredibile crudeltà una madre e una figlia che poi non si rivedranno più per nove anni e una sorella che non incontrerà mai più i suoi fratelli se non per il funerale del padre. Che barbarità un padre con cui non parlare, un padre che ti fa compiere il cammino della vergogna vestito da donna nelle strade del tuo paese natio quando scopre che tu, figlio, sei gay. Certo, poi ti abbraccia durante la notte, ma non è forse anche questa una barbarità? Che barbarità accettarsi solo in segreto, amare l’autenticità di un altro solo quando si è nascosti e non allo scoperto, in pubblico.
I personaggi più spietati di questo breve romanzo sono quelli degli affetti. I più gentili, i più affettuosi, sono gli estranei, gli sconosciuti. E il perché lo scoprirete a pagina 70, oppure rileggendo Un tram chiamato desiderio di Tennessee Williams. C’è il medico che assiste Lucy, un medico di cui conosciamo le mani e il tocco calmo e quella instancabile presenza nei weekend, una presenza che si prolungherà anche negli anni a venire, come una protezione che il mondo non le negherà finché lei ne avrà bisogno. C’è Jeremy, il vicino di sopra, il cui solitario decoro diventa fascino, diventa intimità, diventa intesa: seduti sui gradini della loro casa nel Village, lui le consiglierà di essere spietata nella scrittura (appunto), lei sarà incapace di vedere negli occhi della morte dei tempi, l’AIDS, il destino di lui perché anche in quella morte prevale amore, e a lei interessa solo l’amore. E poi c’è Sarah Payle, la grande scrittrice incontrata per caso in un negozio di abbigliamento e poi inseguita a un convegno alla New York Public Library e a un workshop fuori città, di cui Lucy scoprirà e proteggerà, persino, la timidezza e l’insicurezza. Le proteggerà perché quelle di Sarah non sono le debolezze di Lucy, ma questo fa forse qualche differenza?
A me è sembrato essere proprio questo il messaggio del romanzo: spesso gli estranei sono lì apposta per proteggerci. Gli estranei sono altre versioni di noi, altre versioni – forse migliori – della nostra famiglia. Nell’incontro con lo sconosciuto spesso si sciolgono macigni, si allentano traumi e e si fanno scoperte decisive.
Che nostalgia della gentilezza, in questa realtà.
Recensione di Marta Ciccolari Micaldi
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri