L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Selinunte. Le metope dell'Heraion
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti


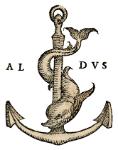




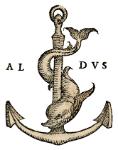

Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (0)

scheda di Castellani, V.A., L'Indice 1995, n. 6
Scoperte nel 1823 da due architetti inglesi, Samuel Angell e William Harris, in Sicilia per rilevare e analizzare i monumenti dell'isola, le metope dell'Heraion di Selinunte costituiscono uno dei cicli scultorei più importanti della Sicilia classica. Erano collocate sui lati brevi dei muri della cella del tempio E (appartengono alla sua quarta fase, tra il 460 e il 450 a.C.), abbattuto, come gli altri del sito, da un rovinoso terremoto che ne dissemin• al suolo gli elementi Quelle conservate, celeberrime, rappresentano: Zeus ed Hera, Eracle e l'Amazzone, Artemide e Atteone, Atena ed Encelado, Apollo e Dafne. Nonostante compaiano già nel 1834 in "Antichità della Sicilia" del leggendario duca di Serradifalco, mancava uno studio esaustivo su di esse.
Marconi parte dalla minuziosa analisi dei frammenti delle sculture, che con una meticolosa indagine d'archivio gli permette di avanzare una proposta ricostruttiva anche per le metope mancanti, condotta anche sul confronto con l'iconografia contemporanea. Vengono così proposti i seguenti soggetti Salomeo e Iride, Crono e Rea, le Pretidi (lato est), Poseidone e Anfitrite, Ares e Afrodite, Peleo e Teti, Atalanta e Meleagro (lato ovest). :Dall'esame delle caratteristiche di lavorazione viene riconosciuta (come già ipotizzò Bendorf) la presenza di due officine, composta ciascuna da una coppia di scultori nel marmo e una nella calcarenite (ricordiamo che le metope sono in calcare con inserti in marmo per il nudo femminile, e in bronzo, non conservato, per accessori come armi o corone.
Identificati i soggetti delle metope, Marconi passa quindi all'interpretazione del loro significato, di grande interesse anche per i non addetti ai lavori. Servendosi del noto schema di Roman Jacobson secondo il quale un'immagine (o un testo) è un messaggio che richiede la compresenza de cinque elementi, un mittente, un destinatario, un contatto, un codice e un contesto, l'autore propone di leggere nel contesto della festa della dea, Hera, cui il tempio era dedicato, il ciclo figurato, tenendo conto che la festa, le celebrazioni "non sono un semplice momento rappresentativo, quanto piuttosto un'occasione educativa per l'intera comunità". Come infatti nota Salvatore Settis nel suo saggio introduttivo, nella città greca il mito, parte dell'identità colturale civica e individuale, si traduceva nei riti della città, nei suoi templi e nelle sue feste. Esso non era solo il racconto di un passato dato per vero: nella polis greca era materiale per la costruzione di un sistema di valori, valido nel presente e nel futuro. Allora, qual è il messaggio che il ciclo delle metope (da considerarsi dunque, a differenza di quanto spesso è stato fatto finora, unitario) vuole trasmettere? La celebrazione del matrimonio, di cui Hera è la sacra custode, quale segno e origine del governo degli dèi sul kosmos (lo 'hieros gamos' tra Hera e Zeus, dopo la vittoria di questi su Cronos sono il punto di partenza del nuovo regno degli dèi olimpi), per gli uomini base dell'intero sistema sociale. È questa la lezione che dovevano trarre le fanciulle di buona famiglia (le fonti attestano una frequentazione soprattutto femminile dei templi della dea) che al santuario si recavano durante le feste in onore della dea, ed è questo il filo conduttore che lega i soggetti delle metope, apparentemente indipendenti tra loro: Hera dà l'esempio sposandosi; Atteone, che desidera la zia materna (Artemide) e quindi viene a collidere con la buona fisiologia dell'istituzione matrimoniale, viene punito; le Amazzoni e Dafne, associate nel comune rifiuto del matrimonio, divengono vittime del destino; le Pretidi sono fanciulle in età da marito riottose alle nozze; le coppie di Ares e Afrodite, Poseidone e Anfitrite ribadiscono il ruolo dell'istituto matrimoniale per garantire stabilità.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


