L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Una passeggiata sotto la pioggia alpina. Testo tedesco a fronte
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti
Prezzo minimo ultimi 30 giorni: 8,80 €



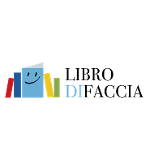


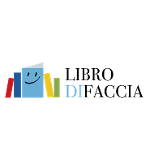
Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (1)

Arriva tardi, questa prima traduzione italiana di uno dei maggiori scrittori elvetici di lingua tedesca. È il testo d'esordio, che Franz Böni, nato a Winterthur, vicino a Zurigo, nel 1952, ha pubblicato giovanissimo, sul finire degli anni settanta. Sono passati meno di trent'anni, ma sembra riemergere da lontananze siderali questa Svizzera in bilico fra pre-moderno e moderno, percorsa a piedi o in bicicletta o tutt'al più, a scrocco, su un vagone merci delle ferrovie da venditori ambulanti, operai sfruttati o licenziati, giovani emarginati. È un universo ancora in prevalenza rurale; sfregiato, certo, dall'industrializzazione: che ha disseminato nelle valli prealpine le architetture sinistre delle fabbriche, e imposto i ritmi brutali del lavoro alle macchine, la presenza ossessiva dei sorveglianti; ma dominato ancora dai rapporti di forza patriarcali dei villaggi contadini, nutrito dal calvinismo gretto di una campagna povera.
E il cuore ideologico della raccolta sta proprio qui: nell'intuizione di una sostanziale continuità fra l'alienazione moderna e l'orrore secolare della vita nei campi. L'esatto contrario dello stanco mito pre-moderno, alimentato da troppi intellettuali Pasolini in primis di qua e di là dalle Alpi. Che continuità innegabilmente ci sia, Böni non lo sostiene con argomenti teorici (quasi non c'è traccia di esplicite analisi sociologiche: per fortuna); lo mostra al microscopio, nel concreto delle vicende narrate. Legge un'oppressione di lunga durata nei dettagli materiali e minimi dell'esistenza quotidiana, nella persistenza di abitudini e riti di una società contadina non meno inumana del nuovo capitalismo: la sveglia prima dell'alba, la coazione al lavoro e al risparmio, l'ossequio alle gerarchie. Le catene sono interiorizzate, si direbbe, per vie filogenetiche; e legano la coscienza anche di quei personaggi che sembrano incarnare, nella loro refrattaria sofferenza, un potenziale di ribellione e libertà: di certo Franz (in Silo), che "aveva solo un problema, il tempo libero", quelle due ore al giorno in cui "proprio non sapeva cosa fare"; perfino A., il protagonista di Il campo di lavoro, racconto a buon diritto conclusivo, che inscena la trasparente allegoria di una Svizzera (e di un Occidente "democratico") mutata in riformatorio, e anzi in lager: "Quando gli venne affidato il turno in stalla pensò che in fondo il soggiorno al campo di lavoro non era poi tanto male". Per una volta, parlare di alienazione è letteralmente esatto: "Il peggio è che sono anche fieri di lavorare in fabbrica", nota un operaio renitente alla disciplina. Non sono molti i testi che hanno saputo tradurre in racconto con evidenza tanto nitida le riflessioni di Michel Foucault sul controllo sociale e la bio-politica. E poco importa che Böni le conoscesse o meno: risalgono agli stessi anni, ed è significativo che gli interpreti più lucidi dei libertari settanta ne colgano il rovescio oscuro. O le avvisaglie di una restaurazione: come, da noi, retrospettivamente, il miglior romanzo italiano su quel decennio cruciale, il recentissimo Piove all'insù di Luca Rastello.
Se quello di Foucault è il primo nome che viene alla mente, leggendo gli otto racconti di cui si compone la raccolta, non mancano (anzi abbondano) gli indizi che suggeriscono di ricollegare Böni a una genealogia propriamente letteraria, scandita da autori fra loro diversissimi, e tutti illustri. Dall'ovvio Robert Walser, cui rinviano origini e temi comuni la passeggiata e la marginalità come forme correlate e rivelatrici di conoscenza, innanzitutto e il perpetuo trascolorare del quotidiano in enigma; a Franz Kafka, per la metafisica del potere burocratico, inscenata in La sedia nella cancelleria, e quella del potere giudiziario, in Corvi, ma anche per l'angosciosa naturalezza di un ineluttabile precipitare delle realtà più banali nell'assurdo e nell'incubo. Probabilmente Thomas Bernhard, per la glaciale radicalità di una lingua esatta, che con calma disperazione accerchia l'indicibile, l'insostenibile. E magari, per un lettore italiano, anche Gianni Celati, cui può far pensare il perpetuo transito, lunatico e disperato, dei reietti di Böni.
Di Una passeggiata sotto la pioggia alpina convince, dunque, lo stile, non meno di quanto feriscano i temi: una lingua secca, acuminata, la cui paratassi insistita ha soprattutto nell'originale tedesco cadenze d'affanno: la precisione analitica rende il dettaglio misterioso, carico d'angoscia, insufficiente. È il paradosso solo apparente di un realismo chiamato a rappresentare nel quotidiano un'oltranza insopportabile: marginalità, alienazione, reclusione.
La resa italiana di Giovanna Wiemer è nel complesso all'altezza, e non era facile riprodurre la tensione stravolta di un dettato apparentemente così semplice. Veniali le pecche: come la scarsa coerenza nella traduzione (o meno) dei toponimi "parlanti", di non poca importanza in un testo che con elusiva ostinazione costruisce geografie al tempo stesso reali e immaginarie. Sarebbe stato opportuno conservare sempre l'originale, e spiegarlo in nota. Wiemer, invece, si regola caso per caso, e non correda il testo di glosse esplicative: di cui si sente spesso la mancanza, perché molte, per lo più sottilmente sarcastiche, e per il lettore italiano assai difficili da cogliere, sono le allusioni a un contesto, culturale e linguistico, prettamente svizzero-tedesco. Un solo esempio: Adrian, il protagonista del primo racconto, Il carrettiere del villaggio, in una campagna dantesca o surrealista, infestata di vespe, vermi, coleotteri e insetti ributtanti d'ogni sorta, trova precario rifugio in un capanno, presso la radura "che veniva chiamata 'Schneckenloch'": non c'è idillio, né solidarietà rusticana; in paese tutti sanno del "vagabondo" che "si aggira" nel bosco, e malevoli ne seguono i movimenti. Per il lettore dell'originale, il nome della radura è citazione trasparente, in beffarda antifrasi, di una filastrocca che nella sua infanzia ogni cittadino (non solo) elvetico di lingua tedesca si è sorbito fino alla nausea (o almeno si sorbiva, qualche tempo fa): quella di Hansdampf im Schneckenloch, cioè nel "buco-della-lumaca" (che a sua volta rinvia, nel mondo reale, a una bella grotta nel Vorarlberg); lo scioglilingua, cioè, del bambino viziato, che "ha tutto quel che vuole, e quel che vuole non ce l'ha e quel che ha non lo vuole".
Più o meno quel che dovevano pensare in cuor loro del giovane Böni i mandarini dell'appagato establishment svizzero, quando il testo apparve, nel 1979, con l'ambizione rabbiosa di corrodere i capisaldi di quella che si potrebbe definire l'ideologia elvetico-russoviana. Sempre brevi e inquietanti, infatti, gli squarci sull'infanzia, familiare e scolastica, dei personaggi: inferno di punizione e repressione. E se gli adulti tanto spesso evocano, con esibita nostalgia, i "bei giorni di scuola", è di certo perché quei giorni "dovevano essere stati talmente orrendi che non li avevano ancora del tutto superati ed erano condannati a parlarne per tutta la vita". Un'osservazione che basterebbe da sola, credo, a misurare la statura di uno scrittore.
I racconti di Una passeggiata sotto la pioggia alpina hanno questo, dei libri importanti: disegnano un mondo circoscritto, irripetibile, e gli danno un senso che ne travalica i confini. Un Oberland zurighese reale e allegorico, calato in un'epoca finita, anzi datato e minuscolo, calcificato nel suo idioletto, ma imprevedibilmente attuale e, si può azzardare con le debite cautele, "universale". Perché la Svizzera è stata anche sarebbe disonesto non riconoscerlo rifugio di libertà (sia pure vigilata), terra d'asilo, oasi di neutralità (sia pure ambigua), in vari momenti della storia del secolo scorso, e in specie nei più bui. Il 24 settembre 2006, un referendum popolare (democrazia diretta oblige) ha approvato con il settanta per cento dei consensi una legge sull'immigrazione e sul diritto d'asilo che definire repressiva è eufemismo: al confronto, la Bossi-Fini è mite e accogliente. È un fatto di portata tristemente epocale: segna la crisi definitiva di un modello di convivenza; di un'ideologia, anche religiosa, della solidarietà; di quelle ospitali "tradizioni" del "popolo gagliardo", cui fa appello il più celebre dei canti anarchici. Potessimo almeno averne anche noi la certezza "in faccia all'avvenir", come in Addio Lugano bella: "Repubblica borghese, un dì ne avrai vergogna". Invece, il presagio è pessimo per l'Europa intera. Naturalmente, non se n'è quasi parlato, sui giornali italiani. Eppure, come Böni sa, la piccola, idiosincratica Svizzera è precisamente al centro del Vecchio continente. Forse, allora, arriva proprio al momento giusto questa prima traduzione del suo primo libro. Purtroppo, la leggeranno solo gli happy few che frequentano le eleganti e coraggiose edizioni Tararà.
Pierluigi Pellini
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


