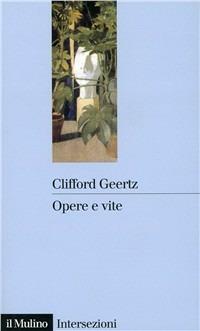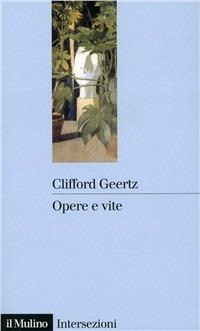L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Opere e vite. L'antropologo come autore
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti

Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (1)

recensione di Remotti, F., L'Indice 1991, n. 3
"Ripensare l'antropologia" è un'attività che ormai vanta una tradizione ragguardevole, a cominciare dal testo canonico di Edmund R. Leach ("Rethinking Anthropology"), la cui pubblicazione risale a trent'anni fa (1961). Molti vi hanno contribuito in prospettive e con obiettivi diversi; non vi è dubbio che parecchi aspetti dell'opera di Clifford Geertz rispondono pienamente ai requisiti di questa meritoria attività critica. "Opere e vite" rappresenta forse il contributo più esplicito, anche se il capitolo introduttivo all'ormai classico "The Interpretation of Cultures" del 1973 (trad. it. "Interpretazione di culture", Il Mulino, Bologna 1987) rimane il testo fondamentale.
Il presupposto principale che anima il libro consiste nella tesi secondo cui, per un periodo decisamente troppo lungo (più di un secolo a partire dal fatidico 1871, anno importante per E.B. Tylor e per L.H. Morgan), gli antropologi hanno concentrato la propria attenzione sui problemi relativi alla ricerca (specialmente il lavoro sul campo), tralasciando, o quasi, quelli inerenti la scrittura (p. 30). Per Geertz, l'antropologia (sociale o culturale) è sostanzialmente etno-grafia, descrizione di culture diverse, e perciò per un verso è attività scientifica di ricerca sul campo e per un altro attività letteraria di esposizione o rappresentazione di ciò che il ricercatore presume di aver colto nell'angolo di mondo da lui frequentato. Troppo a lungo, secondo Geertz, gli antropologi hanno disdegnato, e anzi occultato, questo lato letterario della loro attività, per cui la figura dell'autore risultava relegata ai margini della rappresentazione etnografica: nella prefazione, nelle note, nelle appendici del libri che essi pur scrivevano.
Perché questo oscuramento dell'autore, della sua funzione, della sua incidenza? Farebbe parte di una strategia di auto - ed etero -convincimento, per la quale ciò che viene descritto e rappresentato avrebbe una sua oggettiva autonomia: nella forza scientifica delle cose, degli avvenimenti, delle situazioni, degli aspetti oggettivamente raccolti, a prescindere dalle qualità e dalle contingenze soggettive.
Ma per Geertz la strategia dell'occultamento è qualcosa di più che l'adesione a un mito positivistico imperante nelle scienze sociali e umane a partire dalle loro origini ottocentesche: l'occultamento è strumentale rispetto a un più profondo bisogno di rassicurazione che caratterizza particolarmente l'etnografia. "C'è qualcosa di stravagante - egli afferma (p. 17) - nel costruire dei testi apparentemente scientifici partendo da esperienze ampiamente biografiche", quali sono, appunto, quelle etnografiche. In una prospettiva scientistica, l'eventuale riconoscimento di questa base biografica getterebbe forti dubbi sull'attendibilità dei resoconti etnografici, facendo venire meno il criterio della ripetibilità dell'esperienza. Proprio per questo, "gli etnografi hanno bisogno di convincerci... non soltanto del fatto che sono veramente 'stati là', ma anche del fatto che... se a nostra volta noi fossimo stati là avremmo visto ciò che essi videro, sentito ciò che essi sentirono concluso ciò che essi conclusero" (p. 23).
Il mito scientistico però è tramontato, in particolare in antropologia, con il dissolvimento dello strutturalismo (p. 12), per cui ora risulta facile, auspicabile e doveroso procedere a un'analisi (quasi uno smascheramento) delle modalità di costruzione letteraria dei testi etnografici. Gli autori che Geertz esamina sotto questo profilo (Claude Lévi-Strauss, Edward E. Evans-Pritchard, Bronislaw Malinowski, Ruth Benedict) vengono considerati come fondatori di generi letterari, di discorsività, di stili di argomentazione antropologica, nonostante la loro più o meno conclamata scientificità. Si tratta - questo è chiaro - di modi molto diversi di acquisizione di "sicurezza" (p. 78) antropologica. L'analisi formalizzante e universalizzante di Lévi-Strauss non è il realismo visivo (le "diapositive" etnografiche) di Evans-Pritchard; gli spunti biograficamente problematici contenuti nel "Diary" di Malinowski o le inclinazioni personali della Benedict, in contrasto con l'ambiente intellettuale, consentono a Geertz di trattare questi autori in modo più positivo. Tuttavia la mancata consapevolezza della letterarietà dei loro prodotti induce a ritenere che siano modelli non più proponibili.
Contro i miti e le sicurezze illusorie manifestate dagli autori precedenti, Geertz fa valere la distanza che intercorre tra l'esperienza informe, casuale, bruta, alla base dell'etnografia, e il suo prodotto scritto finale. In questo passaggio si inserisce a pieno l'autore; ma, perdute le certezze di un tempo, affiorano drammatici motivi di "inquietudine" (p. 140). Non si tratta soltanto dell'esaurirsi del mito scientistico. Le inquietudini degli antropologi contemporanei sono anche determinate dal fatto che è mutato il pubblico a cui i prodotti etnografici sono rivolti. Un tempo - osserva Geertz (p. 142) - gli oggetti della scrittura antropologica e il suo pubblico erano del tutto separati, ma oggi vi è un ben maggiore legame e anzi mescolanza tra di loro. Di qui scaturisce una fondamentale "incertezza riguardo all'indirizzo retorico da seguire... Chi dovrà essere persuaso ora? Gli africanisti o gli Africani...? E di che cosa: del rigore empirico? Della portata teorica? Della presa immaginativa? Della profondità morale?"
Lo sgretolarsi delle certezze antropologiche trova la sua ragione più profonda, per Geertz, nella decolonizzazione e nella fine dell'imperialismo. Il crollo dell'imperialismo e il crollo dello scientismo vanno di pari passo (p. 141): se il primo scuote i fondamenti morali dell'etnografia nell"'essere là", nei contesti esotici, il secondo toglie credibilità ai discorsi antropologici fatti nelle aule e nei seminari universitari dell"'essere qui" (p. 144). "Chi siamo noi per descrivere loro?" "In realtà - commenta Geertz (p. 142) - è il diritto stesso di scrivere, di scrivere di etnografia, che sembra messo in discussione". La fine dell'imperialismo è dunque la fine dell'antropologia, come qualcuno aveva già preconizzato (p. 144)? Se il motivo del ripensamento dell'antropologia è il suo carattere letterario troppo a lungo occultato, la soluzione di Geertz consiste in una nuova retorica antropologica, in un rinnovamento della "capacità di persuadere i lettori che stanno leggendo un discorso autentico" (p. 152), non più oscurando la funzione dell'autore, ma esaltandola e raffinandola. Redigendo testi in modo consapevole, l'antropologia rimarrebbe fedele alla sua vocazione di intermediazione tra un Qui e un Là e producendo immaginativamente "connessioni testuali" tra questi due poli, essa costruirebbe un "terreno comune fra coloro a cui si scrive e coloro di cui si scrive" (p. 153).
Di che cosa è fatto questo terreno comune? Di due ingredienti: la vita degli altri, la vita che scorre nei vari Là frequentati dagli antropologi, e le forme letterarie inventate "qui", con cui quella vita viene rappresentata. Il terreno comune costruito dall'antropologia non è altro che questo: "rappresentazione di un tipo di vita nelle categorie di un altro tipo". Per Geertz, anzi, "è impossibile difendere qualsiasi tentativo di farne qualcosa di più". Il ripensamento dell'antropologia provocato da Geertz perviene a un ridimensionamento, drastico, delle sue pretese. L'antropologia come descrizione consapevolmente letteraria delle forme di vita altrui "sarebbe già abbastanza; per parte mia, sono convinto che sia abbastanza, anche se, per altro verso, significa decretare la fine di altre pretese" (p. 153).
Senza avvedersene (forse), Geertz adotta un atteggiamento di ricorso ai "fatti" nudi e crudi, di cui giustamente ci ha insegnato a diffidare. È proprio un "fatto" (per giunta ineludibile) che "tutte le etnografie sono fabbricate a casa propria", per cui si è costretti a ridurre l'intera impresa antropologica a "rappresentazione d'un tipo di vita nelle categorie di un altro tipo" - oppure si tratta dell"'interpretazione" di Geertz, della sua versione dei fatti, della sua "discorsività", del suo orientamento retorico? Proprio seguendo le indicazioni di Geertz, siamo propensi a scegliere questa seconda ipotesi.
Sembra di poter dire che l'antropologia di Geertz (in particolare quella espressa in questo suo libro) sia dominata dall'idea di una bipolarità spaziale: l"'essere là", vale a dire nei contesti esotici, e l"'essere qui", ossia gli ambienti accademici e universitari. Geertz sfrutta in vari modi lo scarto tra il Qui e il Là, fino al punto non soltanto di porre in luce l"'incongruenza" tipica degli antropologi ("qualche anno trascorso ad arrabattarsi fra pastori e coltivatori di ignami e una vita intera a tenere lezioni agli studenti e a discutere con i colleghi"), ma anche di denunciare il senso di falsa naturalezza della collocazione universitaria dell'antropologia (sembra ormai far parte dell"'ordine naturale delle cose" che sotto a ogni antropologo vi sia una cattedra - pp. 139-40).
Geertz rimane imprigionato, tuttavia, in questo schema spaziale. Certo, "i Là e i Qui" risultano oggi "molto meno isolati... delineati... opposti" (p. 156): vi sono antropologi yoruba e singalesi, e i Tongani giocano contro i Washington Redskins (p. 143) Il Qui ha perduto la supponenza di chi un tempo pensava di ordinare il mondo secondo le leggi della sua antropologia. E tuttavia, per Geertz, il Qui conserva la prerogativa della "discorsività" antropologica, ovvero dell'antropologia come discorso e descrizione sui Là: perduta la sicurezza dei concetti scientifici, si è visto che per Geertz la salvezza dell'antropologia consiste proprio nel rinnovamento "qui" delle sue "energie discorsive". Come appare chiaramente in diverse pagine del libro, il Là coincide con il fluire della vita; compito e prerogativa del Qui è "rendere in frasi la vitalità del reale". È come se il Qui, mondo di forme discorsive ed esercizi retorici, avesse bisogno del Là, della vitalità di un altrove: si tratta di catturare il flusso vitale dell'altrove per riempire e vitalizzare le categorie e i gusci vuoti del Qui. L'antropologia per Geertz consiste nell"'immettere le 'loro' vite nelle 'nostre' opere'', anche se si è rivelata a un tratto operazione molto "delicata" sotto il profilo morale, politico, epistemologico (p. 140). Se un tempo il Là era pensato come sottoposto all'ordine scientifico e alle leggi antropologiche del Qui, ora per Geertz - nonostante tutte le cautele con cui cerca di ammorbidire la sua proposta - il Là diventa la vita da descrivere e da immettere nelle opere del Qui: il rapporto tra il Qui e il Là è cambiato (dall'imposizione scientifica alla descrizione letteraria), ma il "fatto" ineludibile per Geertz è che le "energie" antropologiche partono pur sempre dal Qui.
Deludente e irritante, questo ultimo Geertz: ricondurre, se non ridurre, l'antropologia alla sua dimensione letteraria, e così sperare che possa riprendere slancio "qui". L'antropologia, se non è proprio legata indissolubilmente all'imperialismo, è però un fatto esclusivo della civiltà occidentale? Per Geertz, un tempo l'antropologia era spinta dalla "fiducia" che la civiltà occidentale aveva in sé stessa; la consapevolezza letteraria è ora l'espediente per rianimare il suo "spirito di scoperta". Così "non è più il caso di sommergere in un mare di teoria o di metodo i problemi che riguardano l'antropologia della pagina" (p. 157). Ma non vi è anche stato chi invece ha visto alla base dell'antropologia non la "fiducia", bensì il "rimorso" dell'occidente (Lévi-Strauss)? E non è forse pensabile che la crisi di credibilità dei concetti scientifici occidentali - incrementata, se non proprio determinata, dalla stessa antropologia - possa dar luogo al riconoscimento esplicito che i concetti e le teorie esistono anche altrove? Non è forse più equo e produttivo ritenere che in quei Là non vi è soltanto un fluire della vita, che noi ci incaricheremmo di descrivere nelle nostre opere, ma vere e proprie concezioni antropologiche?
L'antropologia ha iniziato il proprio sviluppo scientifico smentendo certe prerogative occidentali (dalla cultura alla religione, dallo stato alla scienza); deve proprio finire ritenendo di essere una peculiarità esclusiva dell'occidente? Uno degli spunti più importanti e decisivi di "ripensamento" critico dell'antropologia occidentale non consiste forse nel concepirsi come una volontà di incontro con le antropologie degli altri? E questo, non in quanto animata da una particolare "fiducia" in sé stessa, n‚ da un rinnovamento delle sue "energie discorsive", ma perché avverte, come un po' tutte le altre antropologie, i limiti con cui "qui" (e altrove) si costruisce l'immagine dell'uomo? Il "terreno comune", lungi dall'essere soltanto un travaso di vita altrui in opere nostre, non è piuttosto un luogo di scambio, di negoziazione, di compromesso, in cui si incontrano e si scontrano I noi e gli altri, e in cui si gettano temerariamente pregiudizi, velleità, aspirazioni, brame di identità e di alterità (nostre e altrui)?
Geertz descrive bene questa situazione dinamica dell'antropologia contemporanea. In un mondo in cui popoli completamente diversi sono "sballottati in una interconnessione senza fine" e dove "è sempre più difficile che l'uno non incroci la strada dell'altro" (p. 156), l'antropologia si presenta come un "gioco disordinato, inventivo, casuale e variabile", dove si intravedono avvisaglie di "qualcosa di nuovo" (p. 157). Che cosa può essere questo qualcosa di nuovo, se non un più massiccio intervento di idee altrui nelle teorie antropologiche (non semplicemente nei "discorsi")? Le quali non "qui", e neppure "qui e là", ma trasversalmente, in ogni dove, si intessono come reti, visto che gli altri - come pure Geertz in diverse occasioni ha insegnato - non si limitano a vivere, bensì sono costretti anche loro a pensare.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri