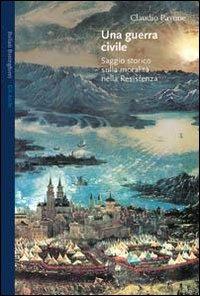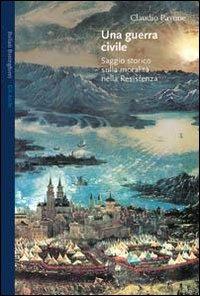L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Una guerra civile. Saggio storico sulla moralità nella Resistenza
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti





Tutti i formati ed edizioni

Anno edizione: 2010
Promo attive (0)

recensione di Isnenghi, M., L'Indice 1991, n. 9
Solo una rivoluzione vittoriosa può rivendicare espressamente i lutti e i traumi di una "guerra civile". O anche, in determinati casi, una rivoluzione sconfitta, che però non tema, abbia anzi l'orgoglio di presentarsi come rivoluzione (p. 224). Altrimenti passa la linea dell'occultamento e della rimozione. Così è stato, per decenni, del 1943-45 in Italia: a parlare di "guerra civile" - in quanto subita sanguinosamente in proprio - era rimasta quasi solo l'estrema destra recriminante e nostalgica. Gli altri, le più diverse correnti e associazioni politiche e combattentistiche dell'antifascismo e del partigianato, si ammantavano virtuosamente di una serie di dinieghi postumi, in nome della "guerra di liberazione nazionale", del "secondo Risorgimento" e di visioni e formule comunque in grado di governare la memoria pubblica e l'immagine del passato, espungendo le parti più sanguinose e inquietanti dell'esperienza reale.
Così quando, con il candore e la fermezza che gli sono propri, Claudio Pavone ripropose l'espressione "guerra civile" (a Brescia, nel pionieristico convegno della Fondazione Micheletti sulla Rsi del 1985; e a Belluno, nel convegno del coraggioso Istituto locale per la storia del movimento di liberazione del 1988), fu uno scandalo. Ma Pavone non si diede per vinto e andò avanti per la sua strada. Fece benissimo. E ora abbiamo in mano questo possente volume di 800 pagine, 600 di testo e 200 di note: un'accumulazione di sapere destinata a restare per lungo tempo definitiva, costruita sulla base di una pluralità e varietà di fonti e di prospettive che fanno già di per sé la ricchezza e l'originalità dell'impianto.
Pavone è un ex funzionario dell'Archivio Centrale dello Stato e qui è sul suo terreno. È un dirigente degli Istituti per la storia del movimento di liberazione e ciò gli ha agevolato l'accesso a una quantità di documenti ufficiali, corrispondenza, materiale, memorie, di ogni possibile gruppo, banda o partigiano nelle più diverse zone d'Italia. Inoltre ha saputo via via rigenerare i propri approcci storiografici, al punto che ci si meraviglia che, in uno storico delle istituzioni quale era prevalentemente stato, siano nati tanto interesse e tanta capacità di maneggiare con sensibilità e finezza i testi diaristici, memorialistici, epistolari e letterari, o le fonti orali: strumenti oggi in auge per l'analisi del "privato" e delle soggettività, non di rado volti a scansare il "pubblico", e che Pavone mette invece al servizio di una strategia interpretativa niente affatto rinunciataria rispetto alla dimensione pubblica degli eventi. La molteplicità dei soggetti è infatti chiamata a testimoniare anche su quel più grande soggetto storico che è la collettività nazionale, frantumata e in sofferenza, negli ultimi anni di guerra. È anche questa freschezza e varietà di approcci e di attrezzatura metodologica che rende attuale e di appassionante lettura un volume di tal mole.
Fin dalle prime pagine - che ricostruiscono il senso di catastrofe e di obbligato ricominciamento avvertito da molti dopo il 25 luglio, e ancora più dopo l'8 settembre - l'idea di moralità contenuta nel sottotitolo manifesta una assoluta centralità: nel trasformarsi da storico delle istituzioni in storico degli uomini e delle loro passioni, l'autore resta fedele all'imperativo di oggettivare quelle passioni e quelle scelte ultime, di ricercare i criteri e definire le coordinate entro e in base a cui, in mezzo a quello sfascio e a quello smarrimento non solamente politico, milioni di giovani e meno giovani si trovarono a scegliere in un senso o nell'altro, o magari anche a scegliere di non scegliere.
Chi "tradisce" chi, e facendo o non facendo che cosa? Quale "giuramento" vale ancora? Su che cosa o in nome di chi fondare o rifondare un'appartenenza o una fedeltà? Non sono domande da moralisti o da filosofi. Pavone, documentando le insicurezze e la demotivazione dell'esercito, dimostra anche che questi interrogativi si posero concretamente, in quell'estremo frangente, a militari e a civili, prigionieri di guerra e giovani di leva, intellettuali e funzionari, all'uomo e alla donna qualunque; e non solo a chi fin poi per compiere la scelta antifascista. Non per niente - si potrebbe osservare - questo taglio rigoristico - a prima vista molto gobettiano, giellista, piemontese - si manifesta anche a Roma (che ha nell'opera una presenza diversa dal consueto grazie alla precisa conoscenza che l'autore dimostra - oltre che delle formazioni politiche maggiori - dei gruppi a sinistra del Pci, dei Gap e dei cattolici comunisti).
"Chi era stato sconfitto nella guerra fascista combattuta fra il 1940 e il 1943? Soltanto il fascismo? O lo Stato italiano con il quale il fascismo si era identificato? o ancor più l'Italia stessa, come entità nazionale storicamente definita?" (p. 169). Questa incalzante serie di interrogativi apre il gruppo dei tre capitoli centrali sulle "tre guerre" - guerra patriottica, guerra civile, guerra di classe - viste come componenti variamente intrecciatesi all'interno della Resistenza e dell'autocoscienza partigiana. È questo il cuore dell'opera, vero libro nel libro, 244 pagine ricche di dati e di analisi tanto sfaccettate da conquistare il lettore, ma scoraggiare qualunque intento di sintesi del recensore. Tutto ruota comunque intorno alla "riconquista dell'identità nazionale", movente patriottico costantemente presente - sia pure in forme diverse nelle differenti aree politiche e geografiche - nelle vicende del Cln; e all'intreccio di questo elemento con le componenti di guerra civile e di classe di cui spesso i partiti così come i singoli militanti e resistenti, non avevano coscienza.
Istruttive le pagine, contenute nei capitoli 4 e 5, sulla lotta per il passato combattuta tra gli uomini di Salò e della Resistenza ma anche all'interno dei due schieramenti, per riconoscersi in una storia negandone altre e agitando in particolare, gli uni contro gli altri, pezzi, personaggi, e inni vari del Risorgimento: "La contesa sul Risorgimento aveva per obiettivo l'appropriazione dell'essenza di quel moto, respingendo nell"antitalia' coloro che si andavano schierando dalla parte opposta. Anche questo non era un fenomeno nuovo. Il carattere di guerra civile è stato sempre negato al Risorgimento, anche negli episodi come la spedizione dei Mille, che videro combattere solo italiani contro italiani. È un processo analogo a quello già descritto a proposito della 'guerra di liberazione nazionale', che porta ad annichilire la nazionalità stessa dei compatrioti militanti nel campo avverso" (p. 265).
Il capitolo 7 dedica ben 100 pagine - e non potrebbe essere altrimenti, data la spinosità del tema - alla violenza: quella, s'intende, rimasta priva di coperture istituzionali, quando lo stato latita o si sdoppia, e una eventuale legittimità del conflitto armato va rifondata su altre e meno tradizionali e tranquillizzanti basi. Qui dunque l'atto volontario di dare e ricevere morte è anche, e specialmente, quello degli antifascisti nell'Italia centro-settentrionale: con informazioni oneste ed esaurienti sui duri sistemi di disciplina e di punizione in uso fra i partigiani, fucilazione compresa; sul trattamento dei prigionieri in un tipo di guerra che, di norma, non consente di tenere prigionieri; sulle rappresaglie e le controrappresaglie; sulla guerriglia urbana e i Gap, fino alla violenza insurrezionale. Claudio Pavone affronta cioè - con assoluto dominio delle fonti e amplissimi riferimenti ai documenti - il groviglio di scelte e di fatti di sangue, banalizzato e involgarito di recente nell'improvvisa fioritura di scandalizzate Vispe Terese che ha riempito per qualche mese le gazzette al grido iroso e giulivo di "Chi sa parli!". Se proprio non m'è sfuggita, non c'è una riga in cui l'autore mostri di accorgersi di questi rumori di fondo.
Il libro poteva forse finire con l'aprile-maggio del '45 e le forme di regolamentazione e inalveamento della giustizia partigiana, sentita insieme come umanamente e politicamente necessaria e in lotta con il tempo: questo, non solo da comunisti e azionisti e dai partigiani più risoluti, ma anche persino da qualche pragmatico ufficiale delle missioni alleate (pp. 508-9). Qui comincia, si può dire, un altro libro, sul Ritorno, vale a dire sulle illusioni e delusioni del dopoguerra, circa le quali l'ottavo ed ultimo capitolo - "La politica e l'attesa del futuro" - offre le prime e spesso suggestive battute (pp. 515-93). Ancora, fra i temi, "La politica e la morale" e - nuovo - quello del rapporto fra le generazioni, 'lunghe' e 'corte', e fra padri e figli. Si arriva, sullo slancio, fino a sfiorare il '68, quando tocca agli ex figli - divenuti a loro volta padri - membri della generazione lunga dell'antifascismo e della Resistenza, essere sottoposti a giudizio e spesso violentemente rifiutati dai figli.
Per gli uni e gli altri - e anche per quelli che verranno - Pavone ha scritto uno di quei lavori definitivi che danno durevole forma storica a una memoria altrimenti vicina a smarrirsi, perché sono morti o hanno cambiato idea molti di quelli che ne erano portatori (si dice che la Rivoluzione sia morta, ma non è che la Patria stia tanto bene): lavori che maturano solo in tempi di bilancio e, se non di congedo, di ripensamento e di svolta. Personalmente, mutato ciò che v'è da mutare, mi viene naturale accostare "Una guerra civile" a un altro memorabile libro, a suo modo nato altrettanto "fuori tempo" e da uguale immedesimazione e pietà storica, sessant'anni fa, che è "Momenti della vita di guerra" di Adolfo Omodeo.
recensione di Revelli, M., L'Indice 1991, n. 9
Solo un partigiano, archivista per mestiere e storico per vocazione, poteva fare un libro come questo: appassionato e appassionante, documentato fino al minimo dettaglio, radicale nei temi e nelle soluzioni. E anche, per certi aspetti, definitivo, così da collocarsi al termine estremo di un ideale percorso storiografico il cui inizio è segnato, inevitabilmente, dal Battaglia della "Storia della Resistenza italiana" (1964). Tra questi due libri "capitali", ci stanno quasi trent'anni di storia dell'Italia repubblicana, e un lavoro storiografico di cui solo ora si può apprezzare l'ampiezza. Battaglia giungeva infatti alla storia della Resistenza in una dimensione per così dire "aurorale" quando rimossa dalla vicenda "patria" negli anni duri del centrismo, si trattava di accreditarla come "evento storico", come vicenda "fondante", Pavone ne traccia un bilancio nello stadio "crepuscolare", ha alle spalle la fase di istituzionalizzazione resistenziale consumata con il centrosinistra, l'emulazione etico-politica del '68, le domande devastanti del periodo del terrorismo, gli stimoli dei nuovi movimenti, a cominciare da quello delle donne, le inquietudini del fallimento della nostra democrazia rappresentativa. Se il primo tracciava sulla base di una memoria vissuta e di una solida stoffa di storico, ma nel vuoto bibliografico di una materia inesplorata, le grandi linee di un abbozzo, il secondo può comporre invece, sulla scorta di un materiale ormai immenso, e su un terreno già solidamente delimitato e organizzato, la trama fitta di un quadro minuzioso, esplorato nei particolari, interrogato nei suoi aspetti più "interiori" (e anche più inquietanti).
Pavone ha considerato tutto quello che si è accumulato in questi anni: la grande storiografia italiana ed europea sulla Resistenza, la memorialistica, l'ormai in buona parte ordinato e classificato materiale archivistico, documenti partigiani e fascisti, giornali di banda, minuta corrispondenza e organici di formazione, epistolari, testimonianze orali e narrativa di genere, insomma la massa sterminata delle fonti elencate nelle oltre 200 pagine di note (un libro nel libro, d'ora in poi imprescindibile per chiunque si avvicini al tema Resistenza). L'ha triturato, questo materiale grezzo, ridotto in frammenti minuti, e poi ricomposto secondo un nuovo ordine, non più cronologico, o politico-ideologico, ma per concetti, per problemi, secondo una linea di argomentazione che taglia il piano degli avvenimenti inventando, per certi versi, un genere nuovo: non storia "solo" politica o militare, n‚ sociale, n‚ tantomeno "storia delle istituzioni" ("l'obiettivo della ricerca venne spostandosi dai programmi agli uomini"). Neppure "storia della mentalità". Potremmo chiamarla forse, storia "morale": considerare il libro un grande "trattato sui sentimenti morali", nel senso più ampio del termine, in quanto sistematico repertorio degli atteggiamenti, delle convinzioni e delle "strutture culturali presenti in esse", soprattutto dei criteri di scelta e delle forme della responsabilità, individuale e collettiva, operanti in un periodo storico "d'eccezione", in una fase di rottura del "monopolio statale della forza" e delle forme "normali" della legittimazione. "Su che cosa gli uomini avevano fondato il loro agire quando le istituzioni nel cui quadro erano stati abituati a operare scricchiolarono o si dileguarono, per poi ricostituirsi e pretendere nuove e contrapposte fedeltà?", è la prima domanda "programmatica" dell'opera, subito affiancata dalla seconda, altrettanto costitutiva: "Se, come e perché sia lecita la violenza quando deve essere praticata senza una chiara copertura istituzionale, nel senso che lo Stato non è più in grado di esercitarne il monopolio".
Il tema centrale dell'opera, provocatorio e coraggioso, è quello della guerra civile. Tema provocatorio, perché infrange un tabù a lungo difeso dalla pubblicistica antifascista, in particolare di parte comunista, impegnata ad accreditare l'immagine legittimante di una Resistenza come guerra patriottica, pura "lotta di liberazione nazionale". E perché da sempre il termine guerra civile è appartenuto alla propaganda fascista e neofascista, al mito negativo della "guerra fratricida", della dissoluzione infamante dell'unità nazionale in cui i valori si annullano o, indifferentemente, l'unico valore diventa il combattimento stesso. È tuttavia coraggioso, perché convincente. Delle "tre guerre" che confluirono nei venti mesi di lotta partigiana, a cui è dedicata la parte centrale del libro - la "guerra patriottica", la "guerra civile", e la "guerra di classe" -, è senz'altro la seconda quella che con maggior nettezza impose la propria "forma" alle altre due, che ne influenzò metodi di combattimento e situazioni di coscienza.
Contrariamente alla guerra tradizionale combattuta per conquistare o difendere un territorio (rispettivamente "di" altri o "da" altri), nella guerra civile i contendenti si affrontano su un territorio che appartiene 'ab origine' a entrambi, e che proprio per questo d'ora in poi non li potrà più contenere entrambi. Dal punto di vista della "cittadinanza", non si pone qui il problema dell"'altro", perché il conflitto non ha per oggetto una "questione di confini", ma la forma stessa della cittadinanza: il suo esito deciderà chi possa esser considerato 'civis'. La guerra civile non possiede neppure una legittimazione preesistente, perché il suo esito è chiamato a fondare ogni nuova legittimità. È il caso limite della guerra totale: non tollera neutrali, n‚ indifferenti (come scrive Roman Schnur, autore di una delle poche riflessioni teoriche sul tema, "tutti i cittadini vengono obbligati a prendere posizione nella guerra civile"), n‚ ammette di essere vincolata da regole o norme. Nella guerra civile - la più feroce, e la più "politica" di tutte le guerre - non vi sono n‚ retrovie n‚ prigionieri n‚ terre di nessuno. Ognuno vi spende, per intero, la propria coscienza, in piena responsabilità. E la guerra partigiana fu esattamente questo.
Essa fu, certo, una guerra civile 'sui generis': intanto perché entrambi i contendenti "italiani" erano in realtà parte di due ben più grandi eserciti contrapposti che li sovrastavano - l'Asse da una parte, gli Alleati dall'altra -, protagonisti marginali di una gigantesca "guerra civile" mondiale; e poi perché i fascisti erano, rispetto ai tedeschi, la parte meno rilevante del nemico, quella che meno condizionava, sul piano militare, i termini del conflitto, così che la liberazione del territorio dallo "straniero" vi aveva una parte preponderante. Ma tutti i caratteri che Pavone meticolosamente ricostruisce attraverso un reticolo impressionante di episodi, espressioni, opinioni, modi di dire, circostanze, problemi - dal reclutamento alla disciplina, dal ruolo dei capi al rapporto con la popolazione, dalla questione dell'abbigliamento a quella dell'amministrazione della giustizia e della formazione dei combattenti -, tutto finisce per configurare la fenomenologia tipica del 'bellum civile'. La stessa assimilazione del fascista allo straniero, quel considerare le brigate nere che rastrellavano all'ombra dei tedeschi, facevano i lavori sporchi per loro, e organizzavano la delazione sistematica, "non più italiani" - l'argomento più forte solitamente usato per contestare la qualificazione di "guerra civile" - ne integra, in realtà, paradossalmente, proprio le categorie più proprie.
Tuttavia, proprio nel momento in cui viene riconosciuta e dichiarata, e in quanto tale resa oggetto di analisi e comprensione, la teoria della guerra civile, anziché confermarlo, falsifica nella forma più piena il luogo comune fascista della "guerra fratricida" in cui le parti si confondono nell'abiezione della patria perduta. Anzi, con più forza emerge la differenza profonda, esistenziale, "morale" appunto, tra le parti in causa. Credo che nessun altro storico italiano abbia, con la stessa apertura e disponibilità, preso in considerazione le "ragioni degli altri", dei combattenti della Repubblica sociale, come ha fatto Pavone. Il suo metodo, di una meticolosità "giudiziaria", programmaticamente attento a non ricondurre l'eterogeneità del reale a schematiche uniformità ma piuttosto a lasciar convivere le contraddizioni aperte, le eccezioni accanto alle norme, lo ha portato a visitare l'universo morale fascista con lo stesso rispetto, e la stessa sistematicità, con cui ha ricostruito quello partigiano: attento soprattutto alle omologazioni, alle comunicazioni di comportamenti, valori, linguaggi, alle strutture comuni dell'agire nella "guerra civile", appunto. Alcune assonanze le ha trovate. Ma nella sostanza i due campi si sono rivelati sostanzialmente opposti. Due in particolare sono i luoghi della differenza: la modalità di ingresso nella guerra, e l'atteggiamento sulla gestione della guerra. Vi sono dedicati i due capitoli più belli: il primo, intitolato "La scelta", e il penultimo sulla "Violenza".
È significativo che il libro si apra con l'intenso capitolo sull'8 settembre e sullo "sfascio" che ne seguì, un tema cronologicamente successivo a quello del secondo capitolo, dedicato preliminare a tutto, perché traccia in realtà i confini del "campo della scelta" entro cui s'inscrive l'intera materia. Ne fissa le coordinate di fondo: la problematica del "vuoto istituzionale" e della "scelta fondante". Nel descrivere il crollo del vecchio stato, la dissoluzione di tutte le istituzioni, la delegittimazione di tutte le autorità, lo straordinario e catastrofico "vuoto" che allora si creò, pone infatti al centro l'essenza etica e politica di quella fase: la necessità, per ognuno, di "scegliere" in forma autonoma, libero da ogni vincolo istituzionale, sulla scorta esclusivamente del proprio repertorio di valori. È quello che Pavone definisce, con le parole di Sartre, come uno straordinario ''ampliamento del campo del possibile" e insieme un improvviso assolutizzarsi del campo della responsabilità ("responsabilità totale nella solitudine totale").
Nella guerra civile ognuno entrò in base a una libera scelta: e le due parti vi entrarono in modi diametralmente opposti, pur nella confusione e talvolta nell'intreccio dei sentimenti (ansia, vergogna, paura, sollievo, senso di abbandono, rancore...) La discriminazione principale sta nel rapporto con l'obbedienza e la trasgressione: "Il primo significato di libertà che assume la scelta resistenziale - annota Pavone - è implicito nel suo essere un atto di disobbedienza. Non si trattava tanto di disobbedire a un governo legale, perché proprio chi detenesse la legalità era in discussione, quanto di disobbedienza a chi avesse la forza di farsi obbedire. Era cioè una rivolta contro il potere dell'uomo sull'uomo, una riaffermazione dell'antico principio che il potere non deve averla vinta sulla virtù... La scelta dei fascisti per la Repubblica sociale... non fu invece avvolta da questa luce della disobbedienza critica. 'L'ho fatto perché mi è stato comandato' sarà, come noto, il principale argomento di difesa". Gli uni interpretarono la prosecuzione della guerra come una forma di liberazione da un passato intollerabile ("un senso di serena accettazione del fatto di essere finalmente dei fuorilegge in un mondo impossibile" scrisse Franco Venturi); gli altri come estremo atto contro un futuro vissuto in forma di destino. Così la scelta partigiana poté costituirsi in un rapporto di consonanza - non, si badi, di identità - con la maggioranza del popolo italiano, vivendo il proprio sacrificio d'avanguardia come mezzo estremo per riscattare quel popolo dall'infamia di un regime fallito; quella fascista si costituì invece in rancoroso spirito di vendetta contro quello stesso popolo che non aveva saputo essere all'altezza dei suoi capi, e visse la propria guerra come lo strumento di una minoranza "eroica" per costringere un popolo di rinnegati a una fedeltà che più non sentiva. Per questo, può concludere Pavone, è l'8 settembre la vera discriminante: "Ancora oggi considerare l'8 settembre come una mera tragedia o come l'inizio di un processo di liberazione è una linea che distingue le interpretazioni d'opposte sponde".
La seconda discriminante è la violenza. Non certo il dilemma "violenza sì / violenza no". E nemmeno, in fondo, il tipo di violenza praticato: la guerra civile è per sua natura una guerra feroce, combattuta all'insegna del "Pietà l'è morta", anche se Pavone dimostra che mai le formazioni partigiane giunsero anche solo lontanamente al livello di efferatezza di quelle fasciste e tedesche, all'ostentazione della morte e alla sua pratica indiscriminata. Ma la differenza sta soprattutto nel modo di vivere la violenza. Ed ha a che fare strettamente con quella scelta iniziale di cui si è detto. Il libro passa in rassegna la complessa e ricchissima problematica della violenza propria della guerra partigiana: dalle tattiche di combattimento (lo scontro aperto, l'imboscata, la guerriglia in città di Gap e Sap) al problema della disciplina e all'amministrazione della giustizia (i tribunali partigiani, le fucilazioni, le sanzioni, il trattamento di prigionieri e spie), dal tema della rappresaglia e degli ostaggi a quello della tortura. Sono considerati un'infinità di documenti, circolari, raccomandazioni dei comandi sulle questioni degli "eccessi" e sul trattamento da riservare a nemici, spie, autorità... Si giunge ad analizzare addirittura la microfisica dei sentimenti e della vita di banda (i nomi di battaglia, i testi delle canzoni,...) E su ogni tema, pur tra contraddizioni, eccezioni, smentite, emerge comunque una grande discriminante tra quella che potremmo chiamare l'estetica della morte di parte fascista e l'etica della vita di parte partigiana.
Al centro del fitto lavorio dei comandi e dei commissari politici c'è, in fondo, sempre il tentativo di giuridicizzare la violenza inevitabilmente alta propria della guerra civile, di regolamentarla, di ricondurla in qualche modo a norme. In sostanza, di contenerla in modo tale da distinguersi sempre dall'avversario ("non dobbiamo esser come loro", è il tema ricorrente), nella consapevolezza di come proprio la condizione specifica della guerra civile (la rottura del monopolio statale della violenza e la trasformazione dei cittadini "da strumenti e beneficiari della violenza statale in gestori in proprio della violenza") ne muti significato e valore simbolico. E di come il rischio di cadere negli opposti "eccessi" del "cinismo" (della pratica impersonale, burocratica, fredda di una violenza weberianamente "professionalizzata") o della "bestialità" (dell'odio e della passione contro un "nemico totale"), sia sempre presente in una guerra senza divise, n‚ autorità tradizionali. Contro la "seduzione della violenza" in nome di una concezione di essa come "dura necessità" sembra essersi mosso, in qualche modo, il processo di "civilizzazione" della guerra civile partigiana, contrariamente alla dinamica del campo fascista, in cui l'estetica della morte (e la seduzione della violenza come valore espressivo in sé) sembra - pur, ancora una volta, con tutte le eccezioni del caso - esser stata prevalente: "Anche nei fascisti - annota Pavone - la cultura della morte non escludeva la figura della vittima innocente, ma tra il crocifisso e il fascio littorio, come aveva visto Georges Bataille nel 1938, il simbolo più congeniale era per i fascisti il secondo, che aveva come elemento costitutivo la scure delle esecuzioni capitali". E conclude: "La morte arrecata ad altri aggredendolo è parte della cultura fascista; e la morte propria e di quelli della propria parte è un elemento integrante di questa mistica mortuaria, che spinge perfino ad aumentare, rispetto al dato reale, il numero dei propri caduti. Nei resistenti, invece, la possibilità di essere uccisi appare soprattutto come un pegno dato alla propria coscienza di fronte al diritto che si riconosce di uccidere".
Merito di Pavone è quello di non aver ridotto questa antitesi a generiche "categorie dello spirito", a polarizzazione di "tipi umani" antropologicamente contrapposti (sottolinea anzi più volte quanto fosse sottile il confine tra le diverse scelte, e quanto dipendesse dal caso la collocazione nell'uno o nell'altro campo), ma di averla ricondotta alla storia, alle diverse posizioni storiche con cui le due parti entrarono nel conflitto (ancora la "scelta fondante") e lo combatterono. Gli uni con un rapporto forte, costitutivo, con il futuro ("abbiamo troppo futuro davanti a noi, per sporcarci le mani", dirà una partigiana, nell'opporsi a una fucilazione inutile); gli altri con un vincolo cupo, rancoroso, con il passato. Con spirito di riscatto gli uni, con spirito di vendetta gli altri. Riscattati dall'avere una storia da costruire i primi; condannati alla perdita della storia, a una simbolica rappresentazione della propria morte storica i secondi.
Forse una cultura ottimisticamente aperta al futuro, come quella dell'antifascismo resistenziale, apparirà obsoleta, nella sua programmatica "positività", a un'epoca che, perduti entrambi, futuro e passato, coltiva nel suo eterno presente flebili pensieri e nessuna speranza. Ma resta il fatto che essa riuscì a produrre uno dei pochi periodi storici in cui la politica poté realizzarsi - per usare l'espressione di Hannah Arendt - in forma di "felicità pubblica". E che su di essa si costituì una delle poche classi politiche del nostro paese degne di questo nome. L'avercelo ricordato oggi, non è di poco conto.
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri