L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Funerali di Stato
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti




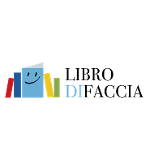








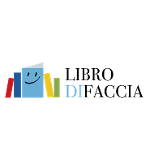



Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (0)

SCHMID, THOMAS, Funerali di stato, manifestolibri, 1991
MISSIROLI, ANTONIO, La questione tedesca, Ponte alle Grazie, 1991
COLLOTTI, ENZO, Dalle due Germanie alla Germania unita, Einaudi, 1992
recensione di Boehme-Kuby, S., L'Indice 1993, n. 1
Missiroli tenta di ricostruire la questione tedesca nella sua intera dimensione postbellica ripercorrendo le principali fasi politiche secondo i concetti affermatisi nella storiografia occidentale che scandiscono la contrapposizione strategica dei due principali vincitori della seconda guerra mondiale: "guerra fredda", "coesistenza pacifica", "distensione", "fine della guerra fredda con la rivoluzione del 1989". Limitandosi per lo più alla storia istituzionale Missiroli fornisce un quadro complessivo ricco di dati e dettagli (molto utile l'apparato di annotazioni a piè di pagina), un vero "reference book-informatissimo e aggiornato", come constata Franco Andreucci nella sua breve prefazione, che non sfugge però al rischio di presentare il percorso storico quasi come compimento di un destino già implicito nelle premesse.
Per esempio: "Il nuovo inizio", ovvero l'unificazione nazionale del 3 ottobre 1990, è stato possibile "grazie al successo dell'altro modello di società, grazie cioè al graduale consolidamento del sistema parlamentare e del liberalismo (politico ed economico) nello Stato tedesco-occidentale, dalla democrazia 'protetta' dell'era Adenauer al 'Modell Deutschland' degli anni settanta e ottanta" (p. 14). E l'attrazione esercitata dal "magnete tedesco-occidentale attivo fin dal 1949" spiegherebbe, secondo Missiroli, come "l'unificazione per semplice 'adesione' alla Brd... sia stata lo sbocco più logico della rivoluzione democratica dell'autunno 1989 in Germania orientale" (p.15). A mio parere questa affermazione contiene un equivoco: per "rivoluzione dell'autunno del 1989" si intende quel movimento eterogeneo che reclamava dall'interno una riforma democratica della Ddr stessa e che è stato escluso dalla scena politica molto presto, mentre il percorso che ha portato all'adesione, ovvero all'annessione 'tout-court' alla Repubblica federale appare "logico" solo nell'ambito degli interessi del capitale occidentale e delle forze dominanti della Rft. Con l'unità tedesca si è aperta, per Missiroli, una "seconda possibilità in questo secolo, dopo Weimar, di trasformare lo stato nazionale tedesco in una grande forza per la libertà e per la democrazia''- proprio questa aspettativa è stata invece delusa dalle modalità e dai tempi mozzafiato del processo "che ci ha recato in dono l'anacronismo di un nuovo stato nazionale" (Schmid), processo descritto da Schmid e da Collotti con grande pertinenza proprio nei suoi aspetti autoritari e di strumentalizzazione delle ingenue aspettative di maggiore benessere e di libertà personali della popolazione tedesco-orientale.
Secondo Missiroli: "È stata dunque prima di tutto la moneta ad unire la Germania, ma non a causa di un improbabile nazionalismo da 'Wirtschaftsunion', priva di valori civili positivi, come ha sostenuto Habermas, e neppure di un altrettanto improbabile trionfo del solito 'impolitico', bensì come forza materiale concreta (la promessa di un benessere atteso invano per quarant'anni) e, allo stesso tempo, come simbolo di industriosità, di efficienza, di stabilità e di responsabilità collettiva" (p. 15). In realtà i cittadini dei nuovi Länder orientali hanno avuto modo, nel frattempo, di rendersi conto della carica di "promessa" insita nel marco tedesco, che più che "simbolo di stabilità e di responsabilità collettiva" rivela il suo tratto fondamentale quale merce più pregiata nell'economia di mercato.
Collotti invece restringe la sua ricostruzione storica delle vicende tedesche all'ultimo ventennio, ricollegandosi alla sua "Storia delle due Germanie" del 1967, ancora fondamentale nonostante il "cambio di prospettive". Collotti descrive in modo molto articolato le conseguenze contraddittorie della Ostpolitik degli anni settanta: per la Repubblica federale si trattava dell'esigenza di uscire dalla situazione di stallo prodotta dalla politica di Adenauer (e di Schumacher) negli anni sessanta (basata, dal 1949, sull'aspettativa di un rapido crollo economico della Ddr). Una presa d'atto della realtà consolidata dell'est europeo si imponeva e la nuova politica della coalizione Spd-Fdp viene valutata da Collotti appunto come riconoscimento dello 'status quo' postbellico (e come tale fu ancora osteggiato dalle forze conservatrici e irredentiste), e quindi come "punto di partenza" (e non di arrivo!) per un nuovo tipo di rapporti intertedeschi che includeva un avvicinamento ("Wandel durch Annäherung") mirante anche a trasformare lo 'status quo' delle due Germanie. Anche nella Ddr si era imposto con l'era Honecker un maggiore realismo politico, "essa aveva alle spalle il consolidamento delle strutture politiche" ed era "divenuta l'ottava potenza industriale del mondo" (p. 127): "La normalizzazione dei rapporti era necessaria se non altro per alienare uno stato di tensione quasi permanente che si ripercuoteva anche all'interno della Ddr; d'altra parte la Ddr era più che mai preoccupata, nel momento in cui entrava a pieno titolo nella comunità internazionale, di preservare la propria specificità e la propria identità nazionale" (p. 151). Collotti rileva così un nodo centrale della questione tedesca: "La rottura definitiva dell'accerchiamento di cui la Ddr era stata fatta oggetto ad opera della Repubblica federale ('dottrina di Hallstein')" (p. 149) e, cioè, il riconoscimento internazionale di un secondo stato tedesco non avevano scongiurato "l'ipotesi di una riapertura della questione tedesca come questione di una riunificazione, a scadenza più o meno breve", anche se la stessa logica della Ostpolitik non la considerava "di immediata attualità". Quindi, la ''normalizzazione" tra le due Germanie era sì un contributo "alla stabilizzazione del lungo processo distensivo in atto sul continente europeo" (p. 151), ma implicava per la Ddr "la persistente attualità del problema della separazione... smentendo ogni possibile speculazione sulla 'convergenza' tra i due sistemi" (p. 152).
Vorrei aggiungere: fu anche questo stato di cose a impedire che la frontiera fra le due Germanie potesse diventare una frontiera come le altre in Europa, essa non poté garantire una cittadinanza autonoma da quella della Bundesrepublik alla popolazione della Ddr (la Repubblica federale considerava ogni tedesco dell'est anche un cittadino federale) e gli organi statali si sentirono autorizzati a imporre la forza per fare rispettare i confini di stato. Gioverà ricordarlo quando la Repubblica federale non esita a processare quel Honecker che ha guidato il processo di distensione nella Ddr.
Collotti tenta un bilancio della contraddittoria "era Honecker", delle sue aperture e degli arretramenti: "L'esigenza di far blocco e la convinzione nella giustezza della propria linea, proprio a seguito della riassicurazione che apparentemente derivava dalla tregua con l'altro stato tedesco, ebbero sempre la meglio su ogni presa di posizione critica e soprattutto su ogni tentativo di mettere in discussione ruolo, collocazione e posizione ideologica della Sed" (p. 166). Ad onta dei fermenti critici non si traeva "alcun motivo di riesame critico neppure dal consenso che continuava ad affluire in maniera plebiscitaria ai partiti del Fronte nazionale guidato dalla Sed..., esso alimentò una sorta di autoinganno... nella Sed" (p. 167). Eppure, neanche i sintomi di latente crisi politico-sociale che del resto aveva caratterizzato lunghe fasi della Ddr avrebbero potuto "da soli autorizzare la previsione di un rapido dissolvimento della compagine statale della Ddr". E, continua Collotti, neppure il concorso di una serie di circostanze internazionali favorevoli all'unificazione... avrebbe di per sé prodotto lo sbocco del trattato di unificazione del 3 ottobre 1990, se non fosse maturata l'iniziativa della Repubblica federale che, inserendosi nella crisi degli stati del blocco socialista, contribuiva ad un tempo alla sua definitiva decomposizione e alla stabilizzazione dell'area continentale... (p. XI).
Nella "crisi finale della Ddr", tra il tentativo di "difesa dell'identità" (governo Modrow e "tavola rotonda") e la spinta all'unità tedesca, alimentata fortemente dalla Bundesrepublik, non ci fu alternativa. Il cancelliere tedesco era stato esplicito già nel novembre del 1989, nel suo "Piano in dieci punti": l'offerta di "aiuto e collaborazione" era subordinata ad un 'irrevocabile' "cambiamento radicale del sistema politico ed economico della Ddr" (pp. 253-54). Nelle elezioni del 18 marzo 1990, sottolinea Collotti, Kohl sfruttò abilmente "il consenso apparente, di fatto la passività della popolazione della Ddr, sempre più disorientata tra la lentezza forse inevitabile del processo di riforme e l'aspettativa che il rapido arrivo della D-Mark avesse a sbloccare una situazione irta di incognite" (p. 258). La Allianz für Deutschland, capeggiata da Kohl, ottenne ampio consenso, il 48 per cento dei voti e formò il nuovo governo De Maizière, subordinato a Bonn, mentre, vorrei ricordare, il 52 per cento si era espresso contro la demagogia di Kohl, ma era un voto frammentato, incapace di costituire un'alternativa (cfr. p 263). Infine Collotti sintetizza le posizioni critiche di singoli intellettuali tedeschi, spettatori impotenti del processo in atto: "Questi tedeschi venivano privati dal loro amore-odio; per i tedeschi dell'est era un pezzo della loro identità che veniva meno; per i tedeschi dell'ovest che non si erano mai identificati interamente con il loro sistema, ma che ne avevano per l'appunto colto la 'provvisorietà', cadeva il punto di riferimento della loro speranza nel cambiamento del sistema" (p. 329). E a proposito delle speranze deluse di Schmid circa l'auspicato atto costitutivo di una "nuova società, che nasceva dalla volontà sovrana dei suoi cittadini", Collotti non può non notare una certa debolezza dell'analisi politica concreta: "Era come se nella Ddr, che non era mai stata accettata così come era, fosse stata investita un'aspettativa, senza però mai porsi concretamente il problema di come realizzarla e soprattutto mai riferirsi alla sorte dei suoi abitanti ed ora, al momento della resa dei conti, non era l'aspettativa a realizzarsi ma la Ddr a scomparire" (p. 329).
La lunga riflessione di Schmid, tagliente nella sua critica del tanto enfatizzato "trionfo dell'occidente", mette a nudo molte delle incongruenze, delle contraddizioni e delle ipocrisie che hanno determinato il processo di unificazione, descritto da Schmid come vera e propria colonizzazione, ma sembra fermarsi spesso a metà. Il limite dell'argomentazione di Schmid sta, a mio avviso nel fatto che egli rimane vittima della sua stessa illusione di fondo (e questa posizione sembra emblematica per tutta la sinistra postsessantottesca), quella, cioè, di poter partire dall'esistenza, nella Rft, di una "società civile consapevole della sua articolazione e della sua ricchezza conflittuale che si vede esposta alla pretesa "ineluttabilità degli eventi e ad una difesa ad oltranza dello stato nazionale". Se è vero che "la Repubblica federale... era sulla buona strada per trarre vantaggio da una sovranità incompleta sul piano del diritto internazionale", meno plausibile appare la deduzione: "Vi erano buone ragioni per supporre che anche la classe politica della Rft avrebbe reagito con prudenza agli sconvolgimenti internazionali e che, in una situazione tanto delicata, non avrebbe sfruttato fino in fondo gli spazi di azione che si aprivano" (p. 70). Secondo Schmid la Rft "avrebbe potuto e dovuto rispondere agli avvenimenti... con le virtù di attendismo e prudente diplomazia... e con la sensibilità civile di una società formata di gente che ha girato il mondo e non è quindi più disposta a mettere al primo posto tutto ciò che è nazionale" (p. 70). E alle obiezioni, ormai rituali, che la Rft "sarebbe stata di fatto costretta ad agire dinanzi al pericolo di un vuoto politico, n‚ l'entusiasmo dei tedeschi della Rdt, n‚ il forte movimento migratorio avrebbero lasciato altre possibilità" (p. 70), Schmid non oppone un'analisi dei nessi causali e dei reali interessi della politica di potenza tedesco-occidentale, ma sentenzia: "Non sono argomenti. Chi li avanza ritiene di poter estorcere un assenso, sciorinando una sequela di fatti contingenti per evitare i quali non sono state messe in moto le capacità di reazione dello Stato e della società civile" (p. 70). E chi avrebbe dovuto "mettere in moto" quelle capacità di reazione se non la presunta società civile stessa? Non costituisce proprio questa soluzione della questione tedesca un clamoroso esempio del fatto che lo spazio della "società civile", in quanto opposizione democratica reale, si dissolve come una fata morgana quando si tratta di operare le scelte di fondo che determinano l'assetto di potere internazionale dei gruppi capitalistici dominanti, anche a livello nazionale? La porta lasciata aperta "al fantasma del Reich" nella formulazione della Legge fondamentale (1948) circa l'obbligo alla "riunificazione" "definiva, solo negativamente, uno stato di attesa", constata Schmid "e tralasciava invece di riconoscere alla nuova compagine sociale una possibile autonoma dinamica politica, che, nell'ora del 'compimento', avrebbe potuto far sentire il suo peso. Quando quel momento è arrivato l'opera di compimento dell'unità è stata riservata alle autorità competenti... L'intero popolo tedesco, cui per quarant'anni era stata rivolta quell'esortazione e che per altrettanti era rimasto immerso, in quanto soggetto politico, in un sonno profondo, è stato derubato ancora una volta del suo diritto a darsi una costituzione". E, di conseguenza, "neppure un serio dibattito sulle possibili forme costituzionali o una appassionata discussione sulla storia tedesca degli ultimi duecento anni, ma solo il miserevole tramonto della Rdt" (p. 84). Quel "tramonto" significa di fatto una massiccia deindustrializzazione (indizio, a mio avviso, del fatto che il capitalismo non è in grado di sviluppare ulteriormente le ex economie "socialiste" e quindi "i toni si sono fatti più duri, non si decantano più i dolci frutti della libertà, preferendo far appello con accenti più o meno marziali, al 'dovere nazionale'" (p. 84). La storia dello stato nazionale tedesco offre innumerevoli esempi dl questo atteggiamento: "Anche il metodo è sempre stato lo stesso: Si conferiva alle superiori esigenze della nazione un'aura di sacralità distante, sottratta a ogni possibile giustificazione o critica, così da sospingere la più piccola presa di distanza, la più lieve esitazione o anche la semplice richiesta di una pausa di riflessione verso la sfera del tradimento" (p. 85). Rimane dunque aperto, come aveva concluso Collotti, "non solo il problema della collocazione della Germania in Europa, ma il problema interno dell'unificazione politica e sociale della società tedesca e dei suoi contenuti di democrazia" (p. 333).
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri


