L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri
IBS.it, l'altro eCommerce
Autunno del Rinascimento. «Idea del Tempio» dell'arte nell'ultimo Cinquecento
Cliccando su “Conferma” dichiari che il contenuto da te inserito è conforme alle Condizioni Generali d’Uso del Sito ed alle Linee Guida sui Contenuti Vietati. Puoi rileggere e modificare e successivamente confermare il tuo contenuto. Tra poche ore lo troverai online (in caso contrario verifica la conformità del contenuto alle policy del Sito).
Grazie per la tua recensione!
Tra poche ore la vedrai online (in caso contrario verifica la conformità del testo alle nostre linee guida). Dopo la pubblicazione per te +4 punti


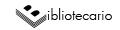

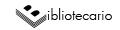
Tutti i formati ed edizioni
Promo attive (1)
Appare in una nuova edizione, con Prefazione di Mario Praz, un classico sulla letteratura della fine del secolo XVI, da tempo esaurito. I trattati d'arte del tardo Cinquecento sono il punto di partenza per una ricerca volta a individuare i principali filoni attraverso i quali si espresse la crisi della civiltà rinascimentale, in un'ottica attenta a riconoscere gli elementi di 'durata' di un'epoca, l'"Autunno del Rinascimento", che fu culmine e tramonto di un'intera civiltà.

Non si può che esser lieti della riedizione, notevolmente ampliata e corredata da un’introduzione di Mario Praz, di un caposaldo della storia della letteratura artistica quale s’impose, già in un lontanissimo 1971, la tesi di laurea discussa da Carlo Ossola con Giovanni Getto. Con la sua scansione adamantina in due parti, Dall’“inventio” alla “dispositio” e Norma e forma (certa), a loro volta suddivise, a specchio, nei capitoli Ut pictura poesis (14 paragrafi) e Bellezza e varietà (5), Invenzioni e capricci (6) e Arte e natura (5), la trattazione procedeva scomponendo e ricombinando, con un piglio mirabile, assertivo e suadente, la trattatistica sulle arti della grande stagione postvasariana. Tra l’edizione dei Trattati d’arte del Cinquecento fra manierismo e controriforma (1960-1962, Laterza) e quella, incipiente, degli Scritti d’arte del Cinquecento (1971-1977, Ricciardi), entrambe dovute alle severe cure esegetiche di Paola Barocchi, Ossola si muoveva con diversa grazia tra i monoliti testuali di Armenini e Lomazzo, Paleotti e Raffaelo Borghini, intaccando la temibile compagine a furia di citazioni, d’incastri e collisioni, da cui sprizzava la fisionomia estetica, gnoseologica, morale di un’intera epoca, quella, appunto, di un “autunno del Rinascimento” altro e distante da quel Manierismo sulla cui esistenza allora si giurava.
Epoca di crisi, comunque, “nella quale la riflessione sull’arte ha avuto (…) notevole importanza”, e su cui Ossola proiettava non solo l’autunnale, eponimo, Huizinga ma le tanto differenti ricostruzioni del maestro Getto e del Foucault ineludibile di Les mots et le choses (Gallimard, 1966) secondo conciliazioni ardite ma credibili. Ne risultava a lui un’età umbratile di slittamenti, decomposizioni, frane del cosmo rinascimentale su cui il Vertumno arcimboldesco, cantato da Gregorio Comanini nel 1591, si ergeva emblema meravigliosamente iridescente. Chiamando spesso in causa Tasso poeta e teorico di poetica, Ossola gli affidava il ruolo altissimo di difensore dell’ultimo equilibrio possibile tra arte e natura, uomo e mondo, simulacri icastici e fantastici, norma, appunto, e forma e gli affiancava, nella trincea di un comune umanesimo cristiano, la precettistica, pur sempre nobile, di Gabriele Paleotti. Nell’attuale edizione l’autore ha voluto incastonare il testo, sulle cui note qua e là è intervenuto, tra la bella e consonante recensione a caldo di Mario Praz (Sotto il segno di Vertunno, in “Il Tempo”, Roma, 9 aprile 1971) e le proprie, odierne, Conclusioni novelle, un saggio del 1975, Manierismo e barocco, uno del 1991, “Autunno del Rinascimento”. Breve storia di un’idea; infine alcune Meditazioni bibliografiche 1990-2013, cioè “recensioni apparse ne ‘Il Sole 24 ore’ nell’anno di pubblicazione dei volumi medesimi e (…) qui riprese, con i necessari ritocchi, entro un ordine che segue la parabola letteraria del XVI secolo”.
Nella seconda delle “meditazioni”, intitolata a Quattro maestri, Ossola con sprezzo sovrano di più timorate collezioni di santini snocciola un altro rosario: Carlo Dionisotti, Eugenio Battisti, Jean Starobinski, Ezio Raimondi. È evidente che la prospettiva risulti, a quarant’anni di distanza, ribaltata su una diversa agenda critica, tanto è vero che “forse soltanto chi ha attraversato il Novecento delle avanguardie può davvero leggere il Cinquecento dei sogni”. L’antico Autunno appare dunque riconfigurato quasi postproduzione di se stesso e, dunque, rileggendolo adesso e tutto di seguito, costretto nei ranghi di una storicizzazione mai banale ma talvolta così ellittica da togliere il fiato (in certi valichi vertiginosi tra epoche e autori) è l’urgenza definitoria, che all’epoca sembrava indispensabile, a risultare sbiadita perché è la nozione stessa di Rinascimento che è saltata ed è Ossola medesimo a ricordarcelo ora in pagine di grande finezza dedicate a Warburg e Carducci e alla “rigenerazione” pagana pretesa dall’uno e negata dall’altro.
A proposito di “provvisorietà delle forme e fugacità della vita”, già nel 1971, l’autore individuava correttamente in Giovan Battista Armenini (De’ veri precetti della pittura, 1586) il testimone lucido della “fine di una civiltà”: col senno di poi l’accentuazione del carattere crepuscolare di questa produzione può risultare talora fuorviante. Negli anni ottanta del Cinquecento, anche nella precettistica figurativa è piuttosto diffusa e fortissima l'esigenza di un metodo tramite il quale siano raccolti e ordinati i “fondamenti immutabili dell'arte”, a uso dei “giovani studiosi della pittura” spaventati “dal convenir impararli con lunghezza di tempo e fatica quasi intolerabile”. Ecco che il richiamo di Armenini alla “maggior brevità” possibile, perseguita nel testo, sottolinea anche l'urgenza di far presto perché una tradizione che è stata eccezionale non rischi di “dare il crollo”. È significativo che il trattatista impieghi l'immagine della selva, topos classico e paradigma dell'enciclopedismo cinquecentesco, per descrivere l'intreccio caotico di saperi e segreti dell'arte, dalla “quale con grandissimo studio et industria”, ha cercato di discernere precetti e regole, per “metterle insieme e farne raccolta in un luogo solo”.
Il metodo è dunque di necessità ambivalente: è stato forgiato con fatica e dispiego di tempo da chi, provvidenzialmente, lo mette ora a disposizione come chiave d'accesso a una conoscenza resa sistematica e quindi fruibile velocemente e con facilità. Il “luogo solo” in cui è stata ricomposta la selva multiforme è comunque suddiviso in una topica esauriente (“e, passando più oltre, trattarò d'un regolato e bell'ordine di accomodar l'opere, secondo che ad ogni luogo si richiede”), necessaria per un corretto adeguamento del soggetto raffigurato all'ambiente, in base a una sistematica applicazione del criterio del "decoro". La stessa ansia tassonomica, su base mnemotecnica e combinatoria, che ispira sia il Trattato (Milano, 1584) che l’Idea del Tempio della Pittura (1590) di Giovan Paolo Lomazzo, persegue più che la meticolosa destrutturazione del mondo la titanica ambizione a soddisfare un’esigenza che era stata prima di tutto di Leonardo, infatti: “se tutti li effetti di natura avessino nome, s’astenderebbero inverso l’infinito, insieme colle infinite cose che sono in atto e che sono in potenzia di natura” (Windsor, Royal Library, 19054v). Non solo dunque frammentazione e dissolvimento in quest’“Autunno” ma soprattutto conservazione del “Rinascimento” secondo una sua talvolta allucinata rifondazione tecnologica.
Massimiliano Rossi
L'articolo è stato aggiunto al carrello
L’articolo è stato aggiunto alla lista dei desideri



